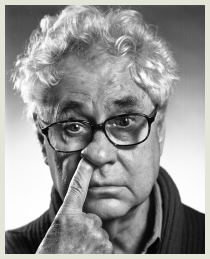 Elliott Erwitt, “Personae”: un mondo in immagini (visto ai musei
S.Domenico a Forlì)
Elliott Erwitt, “Personae”: un mondo in immagini (visto ai musei
S.Domenico a Forlì)
“Personae” retrospettiva che rende omaggio con un’ampia scelta fotografica
ai capolavori del fotografo americano Elliott Erwitt presso i musei S.
Domenico di Forlì è una molteplicità ironica, a tratti poetica o
umoristica, sempre tuttavia profondamente umana di ritratti: i volti delle
celebrità o quelli di gente ordinaria, cani che prendono spesso le loro
sembianze e fanno loro il verso, infine i volti delle città viste
attraverso punti di vista d’eccezione che li rendono unici, icone come tali
entrate nella storia della fotografia. Nella prima sezione in bianco e nero
fino alla metà degli anni ’70 Erwitt si sofferma in particolare sulla
distorsione del punto di vista, spesso prediligendo quello degli animali
che affiancano gli esseri umani e guardano quella stessa realtà dalla loro
postura, nelle loro dimensioni e posizionamento sulla terra con un
implicito risvolto ironico o parodico.
“
Le cose che mi divertono nella vita...le persone senza dubbio_i
paesaggi meno_ quello che fanno nella vita e come si comportano. Tutta
la mia fotografia riguarda questo. I cani sono un ottimo soggetto
perché sono universali e li trovi ovunque nel mondo. Non obbiettano ad
essere fotografati e non chiedono mai impronte..
”
“New York city”, 1974 ( Taking the shot from a tiny dog perspective”)
Cosa significa essere o vedere la realtà dal punto di vista del piccolo e
del minoritario, del basso e non dell’alto, del micro e non del
macroscopico, portare l’attenzione ai piedi anziché alla testa, volgere le
prospettive come in questa immagine mettendosi nei panni di un piccolo
chihuahua umanizzato. La realtà percepita da quella prospettiva appare a
lui enorme, disumanizzante negli stivali neri di cuoio lucidi e militari e
in grandi zampe simili a quelle di un cammello che gli cammina accanto.
Erwitt gioca con i paradossi e si diverte a ribaltare la superficie
traslucida ed edulcorata, troppo educata delle apparenze per decentrare
costantemente con ironia lo sguardo del suo obiettivo, periferico
sull’animale; in particolare assume la misura dei vari prototipi di
cagnetti antropomorfi, abitati di umanità parodiando la medesima per
parlare del mondo che lo circonda.

Nella fotografia divenuta icona erwittiana di New York (1946) per esempio,
la città è vista esclusivamente attraverso un dettaglio fotografico portato
ed espanso in primo piano: i piedi della donna si mostrano enormi,
ingigantiti all’ennesima potenza attraverso i sandali neri sullo sfondo di
un viale alberato e di alti edifici in fuga prospettica verso il fondo. Il
contrasto appare evidente e scherzoso tra la minuscola postura del
Pittsburgh nano che fissa l’obbiettivo e di cui il fotografo assume il
punto di vista e le dimensioni di una realtà estranea, smisurata qui resa a
lui incommensurabile.

I volti delle città allo stesso modo sono filtrati attraverso lo sguardo
erwittiano di questi prototipi canini alter-ego dell’umano. New York è un
viale spazioso nei pressi di Hyde Park democraticamente visto assumendo il
punto di vista del piccolo o del periferico in primo piano. Londra (1966) è
l’interno borghese di un salotto ricoperto di moquette floreale, tappetti
decorati e un sobrio camino vittoriano al centro sul quale troneggia un
orologio a pendolo in suppellettile contornato da minuscole ceramiche e
grandi sontuosi candelabri. Nell’immobilità del luogo un bulldog appare al
centro tra il cinico e il derisorio spossato dal grigiore del lusso
circostante.
Parigi sono le scarpe nere di un charlot dai piedi grandi aperti a punta
verso l’esterno, un boulevard e forse un ombrello, un cagnetto che salta in
aria tra il bianco e il nero prendendo il volo quasi con poeticità e
ironia.

“
Ogni fotografo lotta per quel momento straordinario che trascende il
tempo e il luogo presente, qualcosa che resta e può essere guardato
negli anni a venire. Tale è ciò che chiamiamo magia”.
I corpi sono spesso di schiena dando le spalle allo spettatore nelle
immagini di Erwitt perché si tende a non mostrare l’oggetto in maniera
trasparente come un riflesso immediato di realtà ma invece a sovvertire,
rompere o spostare quella superficie apparente, mondana di semplice
duplicazione del mondo fisico per metterne in discussione implicitamente i
presupposti. In Erwitt si tratta di vedere qualcuno nell’atto del guardare,
per esempio soffermandosi a osservare i visitatori ignari nei musei, o
ancora, di mettere al centro i piedi e non la testa oppure di prestare
l’obbiettivo ai più inusuali punti di vista, spesso a quelli canini.
Interni dei Musei e ironia sull’arte contemporanea
Di Venezia restano le vetrate e i riflessi d’acqua dei canali che
riverberano sui quadri divenuti nudi, lucidi e trasparenti negli interni
dei palazzi antichi. Al Louvre è ancora la parodia sull’arte contemporanea
a far sorridere al centro dell’immagine: in una galleria classica di
ritratti figurativi un gruppo di turisti volgendo a noi le spalle si
sofferma incuriosito su una cornice vuota con un biglietto da visita bianco
al centro: un’opera d’arte concettuale si chiedono, un lavoro in
allestimento, uno sbaglio dei curatori, una cornice temporaneamente
svuotata oppure rimasta vuota per inadempienza. Perplessi e allibiti
fissano la presunta opera contemporanea negligendo completamente le
magnificenti tele classiche. Al Metropolitan, , una statua di nudo
femminile troneggia in bilico al centro sorvegliando gli spettatori contro
i riflessi dei cristalli che rifrangono attraverso i corridoi. Una schiera
di scarpe e cappotti di visitatori al Prado compaiono di spalle di fronte a
una tela: scarpe da ginnastica, in cuoio, con laccetti, lucide nere o
sportive, poi impermeabili, giacche , il gruppo di uomini tutti di fronte
al nudo femminile, la donna ironicamente al lato opposto di fronte alla
figura vestita.
“La mia prima impressione di New York è stato nel 1939 quando sono
immigrato e ho atterrato in questo paese. Una meravigliosa impressione
che continua ancora oggi. Una luogo meraviglioso, quello in cui vivo,
con cui mi identifico, dove è il mio centro ,le mie attività e
famiglia.”
“New York”, 1955 (Empire state Building)
Solitudine e sospensione: lo skyline newyorkese immerso nella foschia
mattutina. Osserva di fronte a lei quella valle di edifici e profili di
grattaceli avvolti nella patina densa e opalescente di nebbia. Elegante,
sobria ed essenziale nell’abito nero si cela in primo piano dietro il
cappello scuro volgendo a noi le spalle. Guarda oltre il parapetto
dell’alta ringhiera, oltre il limite della cancellata in lame di bronzo
appuntite. Getta lo sguardo oltre, su quella valle biancastra rischiarata
dalla soffusa luce dell’alba, irradiante ma velata, distante ma filtrata
dalla densa patina mattutina. Là si perdono anonimi e sfuocati gli edifici
della città sullo sfondo fino alla grande torre in alabastro che troneggia
al centro, maestoso “Empire state building “solo in verticale in mezzo al
grande mare di nebbia. Quasi assumendo l’inquadratura di quello sguardo, il
fotografo ignora gli spettatori, nasconde il volto della donna e riquadra
la fotografia attraverso la potenza del suo soggettivo percepito. Lei,
nella sospensione mattinale dell’alba, nella nebbia di false apparenze e
sembianze illusorie che impediscono una visione netta e limpida della
realtà. La solitudine della metropoli ai suoi piedi ricoperta dall'
ingannevole foschia mattutina.

Fotografia e danza
“
Gli elementi di una buona fotografia sono la composizione in primo
luogo, il contenuto successivamente e un aspetto più effimero, qualcosa
che non si può costruire ma che si riesce a scorgere in alcuni momenti:
l’incanto dell’immagine”
Sono sullo sfondo come profili in controluce; la danza li avvolge sinuosa
come una stretta, dolce come una carezza, tenera un abbraccio. E’ lo
scivolare lento e cadenzato dei corpi nel ritmo del tango, l’ avvolgere
sensuale delle coppie strette nella sala sul linoleum lucido e riflettente
del pavimento. Una simmetria perfetta di corpi delineati nell’ombra
sensualmente danzano su una scena casuale ritagliata dalla luce che penetra
attraverso una porta-finestra sullo sfondo. Svuotati di presenza divengono
icone di loro stessi, “corpi della danza” nell’atto d’essere presi, rapiti,
abitati da un movimento innato.

Danzano ora abbracciati nel corridoio di una cucina a Valencia.
(1952).Sorpresi dallo scatto si lasciano portare dalla melodia casuale
della radio sul sottofondo in pietra dove i loro corpi si muovono tra un
lavabo e un mobile da cucina sorpresi nella stretta intima di un abbraccio.
Ancora danzano bambini abbigliati per una festa durante un ricevimento in
una hall newyorkese svuotata e fredda, forse alla fine dell’evento.
Ripetono seriosamente il rituale visto perpetuarsi dagli adulti, insieme
giocosi e seri, degni nel ruolo loro assegnato del ballo, e con questo
sguardo di innocenza, il piacere celato del gioco mentre paiono prestarsi,
di tanto in tanto in sordina all’obbiettivo.
“
Penso che la cosa più importante di una fotografia sia risvegliare
emozioni, fare ridere o piangere la gente oppure entrambe le cose
simultaneamente. Quando riesci a far piangere e ridere qualcuno allo
stesso tempo come Chaplin faceva è il più alto dei risultati. Un
obbiettivo supremo”.

La fotografia di Erwitt allo stesso modo parte da un “guardare la realtà” e
“interpretare o mostrare quello che si vede” in maniera mai neutrale o con
un unico punto di vista ma, invece, scegliendo di mettere a nudo spesso con
ironia o umorismo la contraddizione o il paradosso insito, in quel
frammento di vita, spaccato di società o di tempo che intende raccontare.
In “Pittsburgh” per esempio (1950) sullo sfondo di un’America
dell’apartheid raziale dominata da un establishment bianco e
conservatore un bambino nero è visto ridere di fronte all’obbiettivo in una
posa scherzosa frontale alla macchina eppure con una pistola giocattolo
puntata alle tempie. In “North Carolina” (1950), le due metà simmetriche
nell’immagine anche visivamente sanciscono la segregazione razziale e
sociale dei neri in America platealmente esposta e etichettata come norma
ancora negli anni sessanta. Nel “white side” una bianca fontanella in
ceramica, nel “coloured side ”un putrido rubinetto arrugginito e stagnante
come protuberanza marginale all’immagine dove un giovane nero sta bevendo.

In “Paris 1949” i ragazzini in strada indossano maschere di Carnevale;
appaiono simili a personaggi fantastici o mostruosi dai volti deformati
mentre accanto a loro si assimilano due ritratti di donne di quel rione
popolare, ugualmente maschere dalle sembianze pittoresche: una venditrice
gioconda di mercato , florida e pettoruta dal volto rubicondo accanto a una
probabile cliente popolana anch’essa una maschera allegra e rupestre. Come
se il mondo fosse questo grande affresco visivo per Erwitt, superficie
meravigliosa, a volte corrosa o incrinata, da svelare con ironia, o meglio
reinquadrare costantemente là dove i concetti di apparenza e “normalità” si
situano sul confine sottile che li separa dal loro contrario facendoci
sorridere e riflettere allo stesso tempo.

Una serie di schermi visivi mostrano costantemente la contraddizione o
l’implicito sguardo parodico portato da Erwitt sul mondo. Schermi sono i
finestrini, i vetri, i dettagli irrisori messi al centro dell’immagine, le
maschere; infine come in “Colorado” lo sparo sul finestrino di un auto in
coincidenza alla pupilla del ragazzino filtra il suo sguardo sul reale
attraverso una frattura o frantumazione del vetro riflettente. Interdizione
a vedere direttamente scegliendo invece la mediazione di una lente
deformante, qui quella di un vetro infranto che potenzia e rende altra la
visione.
Coloured Images (few shots)
“
La fotografia: un’esteriorità meravigliosa che talvolta giunge a
toccare la durezza che si nasconde dietro la maschera. In quanto
fotografo mi occupo di superfici, l’apparenza delle cose”.
Puerto Rico, (Pablo Casals, 1957)
Erwitt dipinse questo paese come un rifugio di grande serenità e bellezza;
i suoi ritratti del noto violoncellista Pablo Casals ebbero un ruolo
fondamentale nella lotta per l’affrancamento del Venezuela dal regime
dittatoriale vigente negli anni sessanta.
Una sorta di dittico di presenza/assenza a colori sullo sfondo della
sontuosità di una tipica dimora amerinda dove il musicista stava
probabilmente ripetendo per un prossimo concerto.
Prima immagine: immersa nella piena luminosità del giorno, la luce filtra
attraverso la grande porta-finestra del magnificente salone nell’ora del
mezzogiorno. Su una scacchiera di bianchi e di neri scivola come la musica
sinuosa e avvolgente, ora lenta e toccante del violoncello nel continuum
dell’esecuzione. Casals si trova totalmente assorto, assorbito e abitato
dalla melodia che sta cercando, componendo o inseguendo all’infinito nella
realtà sublimata del momento presente.
Seconda immagine: una fotografia in assenza. La sedia è vuota in vimini al
centro dello spazio e il violoncello immenso e splendido nel contro-luce
d’ombra vi appare appoggiato contro. La grande sala bianca dalle pareti
nude è immersa nel silenzio, il pavimento a piccoli riquadri è visto a
distanza ora. Nella hall bianca e vuota di fronte alla grande porta
smaltata e i muri decorati di stucchi penetra attraverso la filigrana
sottile dell’ampio rosone al di sopra. Pervade e illumina la sala
sublimando nel silenzio la spazio in una luce rischiarante, quasi divina.
Immagini d’acqua: Salamanca, Brighton and Venice
Salamanca, Spain (1964)
Stende le lenzuola appena lavate sulle rive del fiume nei pressi di
Salamanca. Tessuti bianchi, grandi riquadri candidi e tersi ricoprono
l’erba contro le rive spoglie del fiume immobile nello scorrimento. L’acqua
è stagnante, torpida e ferma a ridosso del grande ponte in pietra a vista
che lo sovrasta. Sulle rive del fiume distese di bianco candore ricoprono
la superficie impervia e sassosa di scorie e sassi lì dove le acque del
fiume vengono a depositarsi contro l’erba inaridita del corso.
Venice (1965)
Palazzi veneziani divorati e corrosi dalle acque; i loro muri in primissimo
piano appaiono mossi, aperti in crepe irregolari, sfaldati dalle correnti
che restano non visibili se non per il loro riflesso sui vetri opachi delle
finestre chiuse. Panni sono stesi tra le due file di persiane. Un
bambinetto esile e magro in bilico cammina ridendo sul bordo del ponte in
fragile equilibrio; avanza in primo piano nello scorcio prospettico
spingendosi fino a noi quasi oltre il limite della foto. L’anima del luogo,
della città d’acqua essenzialmente filtrata attraverso il suo scorcio sul
palazzo.
Brighton (1956)
Una spiaggia d’inverno sulle coste fredde e ventose dell’Atlantico nei
pressi di Brighton, traslucida e brillante come specchio. Semi-nudi, in
costume, con le scarpe levate e i piedi nudi o i pantaloni arrotolati al
ginocchio camminano a riva, avanzano dentro l’acqua, corrono tra le onde,
si allontanano dalla spiaggia, giocano sulla banchina impregnata di limo a
ridosso dell’oceano, chiacchierano, volgono a noi le spalle. Sono di
schiena, di profilo, in piedi, ora un bambinetto a carponi sull’acqua scava
dentro la sabbia. Miracolo dell’istante, composizione arrestata in un
attimo di verità, di vita messa a nudo, esposta e lì colta in quell’istante
effimero e raro che Erwitt definisce “incanto” . Percepiamo tutto
attraverso l’immagine: l’inverno, la patina d’acqua traslucida nel riflesso
del mare nordico, l’Atlantico, il freddo oceano del Nord, la sabbia slavata
dal pallido chiarore solare, i flutti lievi mossi dall’oceano.

Ground Zero, New Mexico (1965)
“Ground Zero”, è terra di confine, rasa al suolo, impervia, al di là della
frontiera Americana o forse al limite tra questa e quella messicana, lì
dove venne lanciato il primo prototipo di atomica nel ‘45 prima
dell’esplosione epocale di Hiroshima. Deserto arido in una delle zone più
remote e impervie della terra, gli arbusti e le asperità delle rocce si
profilano al limite dell’orizzonte evocando la sierra ”oscura" in New
Messico. Dal margine ultimo di una frontiera spostata all’estremo ovest nel
paesaggio americano, dal miraggio di oro e libertà nel suo mito fondante a
“ground zero”, in New Mexico, come a Manhattan dopo l’attacco alle Torri
Gemelle nel 2001. Qui, forse il limite ultimo e irreversibile di un
territorio reso schegge vetrose di deserto dopo la detonazione atomica,
“grado zero” di civiltà nell’estremo cosmico di distruzione prodotto dalle
guerre. (elisa castagnoli)

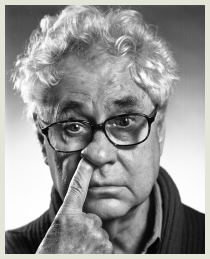 Elliott Erwitt, “Personae”: un mondo in immagini (visto ai musei
S.Domenico a Forlì)
Elliott Erwitt, “Personae”: un mondo in immagini (visto ai musei
S.Domenico a Forlì)














