Lunedì, 29 maggio 2017
Paolo Valesio - Il servo rosso / The red servant (Poesie scelte 1979-2002), con trad. in inglese di Michael Palma e Graziella Sidoli -
Ed. Format Puntoacapo, 2016
1979-2002), con trad. in inglese di Michael Palma e Graziella Sidoli -
Ed. Format Puntoacapo, 2016
Non ho una particolare predilezione per le antologie, comprese quelle
tematiche. Forse perché sono selezioni di selezioni - una cosa che a mio
avviso non ha altrettanto pregio dei superlativi assoluti ebraici (tipo il
santo dei santi, per intenderci) - tanto più se la selezione è opera dello
stesso autore, una autoantologia insomma. Che da una parte può certo
aiutare il lettore, fornendo un fil rouge anche filologico o
interpretativo (e in questo caso copre oltre venti anni di attività), dall'altra chiude l'opera, come potremmo dire travisando un
pochino il pensiero di Eco, Barthes e compagnia bella (cosa a cui mi pare
alluda anche Gian Maria Annovi in una delle note al libro). Nel senso
almeno che il lavoro passa attraverso la distillazione, in primis, del
senso estetico ed autocritico dell'autore. Che fa il punto della situazione
e contemporaneamente - soprattutto se il libro è di una particolare
compattezza tematica come questo - pone la tesi e l'ipotesi dimostrativa,
l'espressione e la dichiarazione di un amor che ha attraversato
quasi senza sosta il pensiero, l'atteggiamento etico, la vita dell'autore.
E che attraversa questo libro.
Un amor che si sostanzia, al livello più evidente, in una
manifestazione - anzi una professione - di fede, in un dialogo con una
presenza trascendente e ubiqua, latente ed evocata, che permea l'urbe e la
natura, e che è il Dio che si può nominare (e si nomina), non quello che si
manifesta inannunciato in una qualche epifania di cui la poesia possa
registrare la meraviglia, è il Dio che popola le preghiere, quello
ricercato con la volontà della parola e con una continuità che richiama
alla mente un esicasmo (qualcosa che assomiglia a una novena o a un
rosario) però inquieto, non pacificante. Una lunga prece, attraverso le
raccolte qui rappresentate, a cui la poesia dà forma e veste, anzi diciamo
meglio, dà una forma pubblica e per ciò stesso non intima, poiché
pregna sia di una volontà di rappresentazione artistica sia di una
testimonianza morale; e insieme privata, non solo per i pensieri che
esprime ma anche, in molte occasioni, per la privatezza del
linguaggio, l'invenzione e l'uso e riuso delle parole, la selezione operata
nel vasto bagaglio culturale dell'autore e la loro dispositio, per
dirla in termini ciceroniani. Ed anche per un certo mettersi in
discussione, a nudo, ad esempio scegliendo di riflettere su momenti critici
della propria vita.
Scelta non facile, in questi tempi in cui non si può parlare di vera agnosi
e forse nemmeno di vera laicità e il relativismo è alibi ancorché vuoto.
Scelta che certo può risultare straniante e forse un tanto escludente, col
suo ricorso ad una speculazione (usiamo per un attimo questo termine)
poetica di questo tipo e tono, di questa qualità di scrittura che mi pare
collocarsi (però altamente sublimandoli) fuori dalla storia e dal tempo
(figurarsi poi dal cosiddetto mainstream), tonalità e scrittura
che però forse assicurano al lettore una giusta distanza "classica" dalla
difficile materia che è chiamato a condividere, risuonando esse a volte come in
una chiesa barocca a volte in una cella claustrale.
E' naturale che quella dell'autore non sia una mera meditazione sul
metafisico o sul trascendentale. C'è innanzitutto in questi versi una forte
coscienza della centralità dell'uomo, dell'essere, della sua capacità di
articolare qui e ora un verbo autonomo, che non proviene da un Ente, ma che
è espressione di una intima umanissima natura, tanto che a volte il dio e
l'io si confondono ("orante io superorale", dice Annovi), una aferesi che rimanda direttamente a una "immagine e somiglianza"
che, a pensarci bene, è insieme nucleo centrale della fede e pesante
lascito e responsabilità per l'uomo. Meditazione sull'evento e la sua
offerta a (o corrispondenza con) Dio, rispecchiamento nel divino o
viceversa in quanto di divino contiene la vita, anche allorquando l'uomo
riscontrasse una sua solitudine, una sua orfanezza da Dio medesimo. Anche
allora, anche in quel dolore, mi pare dicano questi versi, rimarrebbe forse
dubbiosa o incerta ma intatta la coscienza, l'intelletto (e forse
l'orgoglio) dell'uomo di sé, dei suoi limiti ma anche delle proprie forze,
anche nella dialettica costante con l'Altro, o con la propria anima, il
proprio "servo rosso".
Anche la preghiera, se vogliamo, è un'invenzione dell'uomo, la creazione di
un medium, di un linguaggio, di un canale di comunicazione (o comunione), di un sollievo. Invenzione non solo nel senso storico evangelico,
ricordando che il Cristo ne ha insegnata e lasciata in legato una soltanto
- e ricordando anche (tornando sui binomi pubblico/privato,
preghiera/poesia) quel che dice Matteo (6.5-8): "quando preghi, entra nella
tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto" (un
discorso, appunto, di privatezza che la poesia non può né deve
riconoscere); ma anche come artifizio retorico (sia detto senza nessuna
connotazione negativa), esattamente come la poesia stessa, nel suo
istituirsi come "voce" o canto che racchiude in sé la sua bellezza o il suo
fine.
E la preghiera, nella necessità ancestrale dell'uomo, è anche comunicazione
univoca, a cui non segue risposta, o ne segue per vie e manifestazioni
ellittiche o forse non immediatamente percepibili. Ma Valesio, come tutti i
credenti, non ha ragione di porsi il problema, la domanda viene formulata,
o solo suggerita, e magari non è nemmeno una vera domanda ma una
invocazione gettata in aria, ed è questo il senso della sezione del libro
intitolata "Volano in cento (Poesie 1999-2001)", cento "dardi" scagliati
verso l'alto, giaculatorie (di cui "dardo" è calco etimologico) con le
quali l'invocazione si libra e che in sé esauriscono la loro funzione, si
conchiudono come una dossologia, poiché "Se non mi dai risposta questo è il
segno / che mi stai ascoltando". E' l'essenza della fede. Nessuna pretesa
né sicurezza di riscontro, la preghiera (e anche la poesia, tutto sommato)
non è "la formula che mondi possa aprirti": non lo è con certezza, e forse
non lo è nemmeno per Valesio. Ma io credo che nel "contrasto" tra poesia e
preghiera, nella sospensione del tempo che la preghiera assicura, nella
sublimazione e annegamento mistico dentro la poesia e nella
riformulazione della preghiera in quella, nel suo fondo, Valesio cerchi una
sua personale sintesi. Una sua gnosi. (g.cerrai)
Continua a leggere "Paolo Valesio - Il servo rosso / The red servant"
Sabato, 24 maggio 2014

Giulio Marchetti - Apologia del sublime, poesie 2008-2014, Puntoacapo Editrice 2014
Dico subito che la cosa che di primo acchitto sorprende e un po'
inquieta, in questo libro, è la perfetta invarianza dello stile e dei
temi, attraverso gli anni di lavoro poetico che questa raccolta
ripercorre, in tre sillogi diverse gia apparse più una inedita. Niente, o
molto poco, distingue infatti un testo del 2008 da uno di sei anni
dopo, e la cosa, sì, lo ammetto, un po' mi sconcerta, quasi quanto
trovare "I limoni" alla fine di "Satura". Il segno forse è quello di una
fiducia assoluta in un personale idioletto poetico in cui l'autore si
sente confortato, al sicuro, sicuro anche - forse - che il tema stesso,
universale e impellente com'è, imponga di percorrere nessun altro che
quei sentieri con quella voce. Convinzione che certo in parte è
connaturata alla giovane età dell'autore (Marchetti è del 1982).
Parlare d'amore, e riparlarne ancora, non è semplice, sono d'accordo
con la postfatrice Alessandra Paganardi. Il tema è difficile, arcinoto,
scontato, infido e del tutto comune all'esperienza umana, e va
prepotentemente "distanziato", tenuto a bada, se non ci si vuole
affogare dentro. C'è in effetti un certo coraggio in questo canzoniere,
una tenacia nella variazione sul tema (con sconfinamenti
nell'osservazione della natura come cornice dello stesso tema), come un
tentativo di esaurire ciò che nell'esperienza di ciascuno è unico e
inesauribile, nel piacere e, più spesso, nelle pene.
Ma l'amore - qui - è forse pretesto, nel senso letterale del termine, una trama su cui intessere innanzitutto
un lavorìo di parole, una dimostrazione dell'imperio del linguaggio sul
bacino sentimentale e affettivo che quel lavorìo dovrebbe alimentare.
E' questo probabilmente lo strumento principe con cui Marchetti distanzia e
controlla il suo materiale, certo con una riconoscibile competenza, e
lo fa in qualche caso fino a smorzare, almeno apparentemente, quella
certa passione che comunemente si coniuga all'amore. Nel senso
che la primazìa del linguaggio, del "come" dire, è incontrastata, fino a
limitare la sua propria funzione fàtica, l'amore acquista una sua
astrattezza, pare diventare proiezione verso una universalità
trascendente, smaterializzata, un argomento di meditazione sul senso più
generale dell'esistere. E a volte il senso si fa come volutamente
oscuro ("Ledere spasimi avversi equivale a sancire / invariabilmente
l’urgenza regale / della fisicità. Equivale a tendere / l’antico
presagio dell’oltremisura [...]" o anche "Certe sadiche avulse visioni
del meglio / conservandosi al tatto diseguali per indole e forma / quasi
avvertono l’urgenza plenaria dell’estasi pura"). C'è un alto grado di
astrattezza in questa poesia, in bilico tra metafisica dell'amore e
simbolismo, ci sono tanti termini indefiniti, il vuoto, gli istanti, il
tempo delle relazioni è astratto, spesso astratti la collocazione
temporale e fisica degli eventi, il vento, il sogno, la piccola anima.
Eppure da questo punto di vista la poesia di Marchetti è poco "lirica",
assumendo questo termine in senso lato. Il canto infatti talvolta cede
il passo a un tono asseverativo, a qualche dichiarazione aforistica.
Fanno eccezione naturalmente (e forse sono i testi migliori) le poesie
in cui la comunicazione verso l'oggetto dell'amore è diretta, il "tu"
assume una consistenza anche nella sua inevitabile difficoltà a prendere
forma attraverso le immagini della poesia, perché è un "tu" pensiero,
un "tu" luce, come dice Marchetti. Viceversa, quando il lirismo si
riaffaccia, il rischio è quello di certe ingenuità ("quella piccola /
esplosione di ricordi / che ci ostiniamo a chiamare amore" o anche "Ho
smesso di credere ai colori / ma le azzurre profondità dei tuoi occhi /
sono l’unica ragione per cui credo / che esistano due cieli"), nel senso
di espressioni sentimentali note, di accostamenti poetici consueti,
spesso in chiusa del testo, che non sarebbero un problema se fossero
bilanciate da uno scarto poetico, una messa in mora della logica delle
cose, una certa "cattiveria". Forse è per questo che uno dei miei testi
preferiti (quelli che qui ho scelto) è - per fare un esempio - la poesia
"Adesso" (v. sotto), in cui molte di queste cose ci sono, c'è una certa
qual "rabbia" nell'espressione emotiva, nella resa del sentimento buono
o cattivo che sia, c'è una "decisione", la scelta di parole concrete e
"pesanti" in cui anche il poeta può forse rinvenire un ben diverso
sublime. (g.c.)
Continua a leggere "Giulio Marchetti - Apologia del sublime"
Mercoledì, 12 marzo 2014
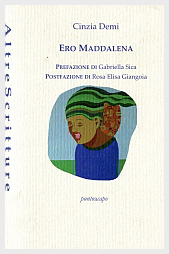 Cinzia Demi - Ero Maddalena - Edizioni puntoacapo, 2013 Cinzia Demi - Ero Maddalena - Edizioni puntoacapo, 2013
Per afferrare tutta la grandezza/bellezza di un’opera poetica bisogna fondersi con la liricità del verso, lasciarsi possedere dal significato delle
immagini, attraversarle come fossero piazze vuote o stracolme di aloni, albe, crepuscoli, vortici di esperienze passate e ricomposte. Il poeta, che
scansiona il reale, rinviene con maestria le voragini che appartengono al mondo e ai suoi altrove, molto spesso luoghi timorosi della Luce e del
plurisimbolismo in essi contenuto. Cinzia Demi nel suo lavoro poetico Ero Maddalena, Edizioni puntoacapo 2013, si inserisce con
consapevolezza raffinata nel surrealismo novecentesco per far emergere parole ed energie dallo stato inconscio, affinché la scrittura poetica possa
liberarsi completamente dei segni inibitori e delle finalità preordinate. L’autrice supera ogni razionalità partendo da una figura biblica, Maddalena, personaggio sotteso da una frangia di immaginario. Maria Maddalena o di Magdala è stata, secondo il Nuovo Testamento, una donna
discepola di Gesù e venerata come santa dalla Chiesa cattolica. Questo personaggio conserva una profondità di spunti riflessivi che ci spingono a ricrearlo
per scoprirlo ogni volta, attraverso gli influssi epocali/storici, fino a ritornare al punto enigmatico, arcaico e iniziatico della figura misteriosa che
rappresenta. Demi, per tutto il suo percorso poetico, riveste di un modo costante la presentazione della donna, quasi sempre votata alla tragica esperienza
del ruolo che ricopre: rende possibili le voci e gli aspetti di un’ombra irreale, che vaga nei vasti dintorni della storia umana, come un evento che si
svela in ogni istante della quotidianità. Maddalena siamo anche noi, infatti, donne erranti in identità che continuamente perdiamo e che continuamente
ritroviamo; Maddalena è la nostra forma inconscia che dialoga con il nostro sé: è l’ulteriore presa di coscienza del disagio socio-psicologico con cui ogni
figura femminile deve fare i conti. Articolazioni senza volto e nazionalità: donne, madri, figlie, di oggi e del passato, distrutte e poi purificate dallo
slancio restaurativo dell’animo umano, sono le protagoniste di questa silloge, preziosa ed elegante, in terzine originali intrise di classicità e
modernità. Le Maddalene perseverano nel mutarsi espansioni di un vissuto nei vissuti: infatti, la donna di Magdala erano e sono tutte le donne che si
proiettano nel mondo in un modo baudelairiano superando, quindi, l’astrazione simbolico/fittizia per calarsi nelle vicende umane più semplici, più sommesse
o precarie, passionali e dolorose. L’autrice contrassegna radici storico/sociali celebrando l’esistenza del percorso poetico/analogico e tracciando
strutture freudiane che si confermano e si contraddicono nel convenzionalismo del riscatto emozionale. La fuga, i tranelli, la nausea, il nome che cerco, un bacio, il portone, il respiro, la chiesa, il sepolcro, la pietà, la semina, le pietre, la cura: parole tematiche e anche
allegoriche che evocano intenzioni precise, implacabili, mettendo spalle al muro l’io neurovegetativo del lettore e che sanno riportarci nel complesso
creato-universo di ripudio/offesa, accoglimento/perdono. (rita pacilio)
Continua a leggere "Cinzia Demi - Ero Maddalena, nota di Rita Pacilio"
Giovedì, 27 settembre 2012
Giacomo Leronni - Le dimore dello spirito assente - Puntoacapo, 2012
Q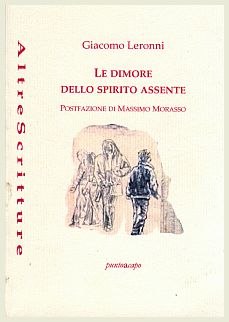 uesta non è una critica e nemmeno una recensione. E' piuttosto una
serie di riflessioni di lettura che prende occasione (e l'autore mi
perdonerà) da un libro non facile, a tratti petroso e lunare, che
domanda a chi lo legge un'attenzione pressoche totale. uesta non è una critica e nemmeno una recensione. E' piuttosto una
serie di riflessioni di lettura che prende occasione (e l'autore mi
perdonerà) da un libro non facile, a tratti petroso e lunare, che
domanda a chi lo legge un'attenzione pressoche totale.
Un libro che guarda al cosmo insondabile della parola, o meglio a
quanto essa possa essere sondabile a piacere, senza arrivare mai -
almeno definitivamente - a una meta (cioè, spesso, a dire cosa). E'
l'etremo rammarico di ogni poeta.
Il limite della poesia sta (o molti sono convinti che stia) nella
estrema plasticità del linguaggio che usa per statuto. Qui "limite" lo
prendo nella sua accezione meno eroica. E' quello cioè in cui sbatti il
naso e ti fermi, guardandoti in giro irrelatamente, e NON quello in cui invece getti
il cuore oltre l'ostacolo e scali la montagna come Messner. E' il
limite quindi oltre il quale la parola, come un diamante su cui si tenta
l'ennesima sfaccettatura, perde la sua funzione e si sbriciola. Può
darsi che diventi rappresentazione dell'implosione dell'universo, o
della sua dissipazione entropica. E questo universo, esattamente come in
un racconto di Asimov, può essere infinitamente grande o infinitamente
piccolo, stellare o mentale. Ma la comunicazione con il lettore diventa
come quei segnali radio che arrivano dal cosmo molti anni dopo che sono
stati generati. C'è necessità di decifrare.
Leronni è abile ad esplorare i confini, il limite di cui si parlava.
Prende l'evento (termine per ora indefinito) e lo proietta sulla volta
del linguaggio, su una griglia dove egli opera una selezione (per dirla
con Jakobson) di parole, ne elude, sempre per rimanere in tema,
l'equivalenza, nonchè le ricombina in un suo personale sistema
metaforico. Per dirla in due parole, l'imperativo sembra essere
l'aggiramento della "norma", assumendo qui il termine in senso lato.
Mi sembrava di avere colto in questa poesia qualche indizio:
Lo descrivo il colore
e s'incaglia
poi di soppiatto
rientra nella norma
la tentazione di captarlo
lo incarcera
la voglia che lo addita
lo annulla
richiamo la pupilla
ritiro la tovaglia del senno
lo lascio allora
spoglio, il colore
innegabile.
A me pare che Leronni descriva bene il procedimento di come si faccia a
liberare poeticamente l'evento (colore, amore o qualsiasi altra cosa ci
ispiri) dalla gabbia delle parole. E' abbastanza superfluo parafrasare
il testo, nella sua pulita linearità, ma notiamo almeno un paio di
cose: il tentativo di afferrare l'evento, di descriverlo, il desiderio
di connotarlo dapprima fallisce, rientra nella "norma" delle parole.
Unico mezzo per sfuggire alla gabbia, secondo il poeta, è spogliare
l'evento, operandone una estrazione dell'essenza, sottraendone la
descrizione alla consuetudine, al "senno" (o forse - e qui sta
l'equilibrio sul difficile limite - al senso). L' "oggetto" diventa
innegabile, il suo "essere" si palesa univoco. E' nella potestà
dell'autore stabilire "un margine sufficiente di univocità" (Umberto
Eco). Ma l'arte (anche quella di Leronni, nei suoi testi migliori) sta
nel capire dove sia e in cosa consista questo margine, almeno quel tanto
che basta per "lasciare al lettore l'iniziativa interpretativa" (ancora
Eco). Il postfatore Massimo Morasso non è molto distante da questi
pensieri, quando parla per questo libro di "carica eversiva della
migliore poesia visionaria (...) come sospesa e trattenuta in un limbo
infralinguistico che sta a noi lettori, leggendo, di riconoscere e far
emergere in pienezza alla luce del senno". Al lettore (leggente) quindi
l'onere della prova? Morasso elude la domanda addebitando il dubbio ad
altri, al personaggio Fine Letterato che usa come controparte. Non importa. Ma il rischio di una una oscurità dell' "anima" (v. più avanti) del poeta forse permane.
Del resto Leronni molto correttamente ci ha avvertiti, nella "Dichiarazione di poetica" posta all'inizio del libro:
"Sfilano gli stracci / della verbosità // si essicca il discorso
paludato // il fasto retorico / uggiola di finitudine // la ridondanza
perde morsi. // Giacciono i fronzoli disattivati / annegano gli orpelli
// si staccano / le cornici esornative: // chi parla adesso è asciutto /
un corpo scarnificato / evaporato // nient'altro che un'anima".
Bene. Vale la pena di sottolineare, magari partendo da questi due
esempi, che Leronni non bara mai sul linguaggio. Non bluffa, non
persegue l'inusuale lessicale, non compulsa il dizionario. Il fraseggio è
quasi sempre limitato a un solo sintagma, per di più quasi sempre
"principale", cioè paratattico, e questo provoca da una parte un
pregevole effetto, compatto, ritmico, e con una sua musica interna,
dall'altra un incedere sibillino, aforistico (o forse sapienzale, come
preferisce dire il postfatore).
Due parole infine sulle poetiche di Leronni. Di una abbiamo detto, ed è
quella principale e fondante: la riduzione del linguaggio, l'
"essiccazione" del discorso, il superamento (ma fin dove?) del limite,
della "dogana" del significato (prendo il termine dal distico
stupendamente emblematico "Quando dico amore è per eludere / la dogana
del senso"), come pure del problema (egli accusa) della "meraviglia
fatta a pezzi / dalla definizione".
L'altra è quella dei "minimi spazi" ("perchè oltre questi minimi spazi /
non risuono", afferma), cioè quella che altrove ho chiamato poetica
degli interstizi, che va spesso insieme al ripiegamento espressivo,
diversa dal minimalismo degli oggetti e dei luoghi, ma piuttosto una
poesia "percettiva" orientata sui riverberi degli eventi sulla psiche. E
sull'interrogarsi, ovviamente, di come sia possibile sfuggire sulla
pagina alla ossessiva e logora verbalizzazione della mente (e forse
della cultura che ci portiamo sulle spalle).
Va invece respinta la domanda se per Leronni sia indifferente il tema,
anche "minimo", purchè serva docilmente alla sua prima poetica.
Ovviamente no: Leronni è poeta sufficientemente fine (come dimostrano degli
ottimi testi) da non trarre sé stesso nel tranello della metapoesia,
cioè del fare versi per parlare di come i versi stessi si fanno. Se la
costellazione di Leronni è oscura (un'oscurità da cui, secondo Morasso,
il poeta prende lezioni), essa è tuttavia ampiamente popolata: l'amore,
l'estetica e l'apparenza, il molteplice, "lo sguardo che vigila sul caso
[e] dispone l'ignoto in bella forma", l'inganno dei sensi, la morte
come luogo abitato, l' "altalena del mutevole". E naturalmente la natura
di cui siamo parte, qui filtrata da un pensiero analitico insonne e a
volte impietoso, da uno spirito tutt'altro che "assente". (g.c.)
Continua a leggere "Giacomo Leronni - Le dimore dello spirito assente"
Giovedì, 9 agosto 2012
Caterina Davinio - Il libro dell'oppio, Puntoacapo Editrice, collana AltreScritture, 2012
 Credo che abbia perfettamente
ragione Mauro Ferrari quando dice, a proposito di questo libro:"Credo
che la difficoltà di accedere alla poesia di Caterina Davinio sia
trovare il (soggettivo) punto di accesso, laddove cioè la superficie
del significante si apre o meglio lacera". Per quanto questo sia
generalmente vero per ogni opera di poesia o d'arte in genere,
nel caso di Davinio l'accento è da porre appunto in quel "soggettivo".
Ma non si tratta qui della soggettiva del lettore generico, con il suo
bagaglio culturale e psichico. bensì di qualcosa di sociologico, o se
volete di impoetico. Perchè in questo libro si parla di droga, con quel
che scatta al riguardo in termini di accettazione, empatia, sospensione
del giudizio, volontà di capire beneficiando del mezzo artistico; oppure
- viceversa - in termini di rigetto, categorizzazione etica o politica,
o peggio ancora morale. Davinio ne ha qualche consapevolezza se - nella
breve nota introduttiva - mette le mani avanti: "Di certe malattie del
corpo e dell'anima forse è meglio non parlare, dissimulare, non turbare
la suscettibilità di chi al mondo riesce a dipartire con tanta sicurezza
il bene e il male, la salute e l'afflizione, il paradiso e l'inferno".
Ma tant'è, archiviamo la cosa a titolo di cronaca, come un rischio che
andiamo a schivare rapidamente. Quel che importa è che poi, alla fine,
Davinio abbia scelto di pubblicare queste poesie, datate 1975-1990,
rimaste nel cassetto per più di un ventennio. Scegliendo di parlare,
invece, scegliendo di costruire con questi testi un border song,
un canzoniere del confine innumerevoli volte attraversato in prima
persona, il limitare tra essere e non essere di cui il corpo, talvolta
smagrito fino all'anoressia talvolta involucro pesante veicolo di
sinestesie feroci, è monade compulsiva su cui anche gli affetti si
frangono, è pietra confinaria di continui tragitti tra piacere e dolore,
tra vita e morte, tra speranza e disperazione. Corpo come luogo quindi
dell'ossimoro (come annota giustamente Ferrari) e quindi degli estremi
entro i quali spesso la ragione ("Ragione! Ragione!
Filo sottile / che sorregge un corpo immenso / multiforme...") e la
logica (come si conviene a tutti gli ossimori) hanno scarsa cittadinanza. Ma per fortuna ce l'ha il
linguaggio, ovvero l'io che si recupera, ovvero la capacità di trovare
le parole per dire. Che, proprio in queste antinomie o paradossi
esistenziali che poeticamente registra, trova una sua bellezza
spigolosa, una tagliente evidenza, una straniata oggettivazione, il
tempo a volte sospeso in apnee o oasi. Elementi che del resto avevo
trovato anche nell'altro libro di Davinio annotato in questo blog (v. QUI).
Vorrei chiarire marginalmente che a mio avviso qui non si tratta di una
poetica del (politicamente corretto) "disagio", qui si tratta di un
onesto libro sulla fame di vivere velocemente, sulla ricerca del piacere
im-mediato e sulla lotta alla noia, e perfino su un periodo della
nostra storia. E conta qui rilevare la consapevolezza artistica che
emana da questi testi, anche dai più immaturi (questo lungo diario
asincrono inizia quando Davinio era poco più di una ragazzina), quelli
per intenderci in cui risenti galleggiare il punk, il rock e soprattutto
il post-post-beat. Ma liberati da questi ammennicoli, da un certo
"letterario ardore" (parole dell'autrice) o da qualche minimale compiacimento al nero, i brani si fanno incisivi e
gravidi di senso e occupano di prepotenza la pagina. (g.c.) Credo che abbia perfettamente
ragione Mauro Ferrari quando dice, a proposito di questo libro:"Credo
che la difficoltà di accedere alla poesia di Caterina Davinio sia
trovare il (soggettivo) punto di accesso, laddove cioè la superficie
del significante si apre o meglio lacera". Per quanto questo sia
generalmente vero per ogni opera di poesia o d'arte in genere,
nel caso di Davinio l'accento è da porre appunto in quel "soggettivo".
Ma non si tratta qui della soggettiva del lettore generico, con il suo
bagaglio culturale e psichico. bensì di qualcosa di sociologico, o se
volete di impoetico. Perchè in questo libro si parla di droga, con quel
che scatta al riguardo in termini di accettazione, empatia, sospensione
del giudizio, volontà di capire beneficiando del mezzo artistico; oppure
- viceversa - in termini di rigetto, categorizzazione etica o politica,
o peggio ancora morale. Davinio ne ha qualche consapevolezza se - nella
breve nota introduttiva - mette le mani avanti: "Di certe malattie del
corpo e dell'anima forse è meglio non parlare, dissimulare, non turbare
la suscettibilità di chi al mondo riesce a dipartire con tanta sicurezza
il bene e il male, la salute e l'afflizione, il paradiso e l'inferno".
Ma tant'è, archiviamo la cosa a titolo di cronaca, come un rischio che
andiamo a schivare rapidamente. Quel che importa è che poi, alla fine,
Davinio abbia scelto di pubblicare queste poesie, datate 1975-1990,
rimaste nel cassetto per più di un ventennio. Scegliendo di parlare,
invece, scegliendo di costruire con questi testi un border song,
un canzoniere del confine innumerevoli volte attraversato in prima
persona, il limitare tra essere e non essere di cui il corpo, talvolta
smagrito fino all'anoressia talvolta involucro pesante veicolo di
sinestesie feroci, è monade compulsiva su cui anche gli affetti si
frangono, è pietra confinaria di continui tragitti tra piacere e dolore,
tra vita e morte, tra speranza e disperazione. Corpo come luogo quindi
dell'ossimoro (come annota giustamente Ferrari) e quindi degli estremi
entro i quali spesso la ragione ("Ragione! Ragione!
Filo sottile / che sorregge un corpo immenso / multiforme...") e la
logica (come si conviene a tutti gli ossimori) hanno scarsa cittadinanza. Ma per fortuna ce l'ha il
linguaggio, ovvero l'io che si recupera, ovvero la capacità di trovare
le parole per dire. Che, proprio in queste antinomie o paradossi
esistenziali che poeticamente registra, trova una sua bellezza
spigolosa, una tagliente evidenza, una straniata oggettivazione, il
tempo a volte sospeso in apnee o oasi. Elementi che del resto avevo
trovato anche nell'altro libro di Davinio annotato in questo blog (v. QUI).
Vorrei chiarire marginalmente che a mio avviso qui non si tratta di una
poetica del (politicamente corretto) "disagio", qui si tratta di un
onesto libro sulla fame di vivere velocemente, sulla ricerca del piacere
im-mediato e sulla lotta alla noia, e perfino su un periodo della
nostra storia. E conta qui rilevare la consapevolezza artistica che
emana da questi testi, anche dai più immaturi (questo lungo diario
asincrono inizia quando Davinio era poco più di una ragazzina), quelli
per intenderci in cui risenti galleggiare il punk, il rock e soprattutto
il post-post-beat. Ma liberati da questi ammennicoli, da un certo
"letterario ardore" (parole dell'autrice) o da qualche minimale compiacimento al nero, i brani si fanno incisivi e
gravidi di senso e occupano di prepotenza la pagina. (g.c.)
Continua a leggere "Caterina Davinio - Il libro dell'oppio"
|
 1979-2002), con trad. in inglese di Michael Palma e Graziella Sidoli -
Ed. Format Puntoacapo, 2016
1979-2002), con trad. in inglese di Michael Palma e Graziella Sidoli -
Ed. Format Puntoacapo, 2016

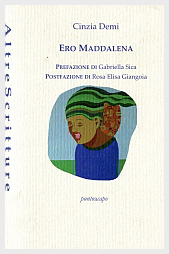 Cinzia Demi - Ero Maddalena - Edizioni puntoacapo, 2013
Cinzia Demi - Ero Maddalena - Edizioni puntoacapo, 2013
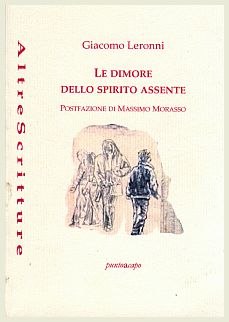 uesta non è una critica e nemmeno una recensione. E' piuttosto una
serie di riflessioni di lettura che prende occasione (e l'autore mi
perdonerà) da un libro non facile, a tratti petroso e lunare, che
domanda a chi lo legge un'attenzione pressoche totale.
uesta non è una critica e nemmeno una recensione. E' piuttosto una
serie di riflessioni di lettura che prende occasione (e l'autore mi
perdonerà) da un libro non facile, a tratti petroso e lunare, che
domanda a chi lo legge un'attenzione pressoche totale.





