Mercoledì, 2 aprile 2014
Giuseppe Samperi - Sarmenti scattiati
Amministrazione
Ricerca veloce
ARCHIVIO GENERALE
Recent Entries
- Sebastiano Aglieco - Infanzia resa, nota di Rita Pacilio
- Pietro Roversi - I pinguini dei tropici
- Jean-Pierre Duprey - Poesie
- Luigi D'Alessio - Louis
- Rodolfo Zucco - Bubuluz, nota di Gabriella Musetti
- Europa in versi: il festival e alcuni testi degli ospiti
- domenica, maggio 6 2018
- Alessandro Silva - L'adatto vocabolario di ogni specie
- sabato, aprile 28 2018
Tags
adelphi editore, adriano spatola, alain jouffroy, alessandra sciacca banti, alessandro assiri, alessandro de caro, alfonso berardinelli, alfredo riponi, amelia rosselli, andrea inglese, angèle paoli, antologia, antonio porta, arcipelago itaca, areale italiano, arte contemporanea, avanguardia, bernard noel, bologna, camera di condizionamento operante, carla paolini, caterina davinio, chiara de luca, copyleft, corrado costa, critica, czeslaw milosz, daniele poletti, daniele santoro, danilo mandolini, davide castiglione, davide nota, derek walcott, diaforia, diego conticello, dino campana, domenico ingenito, dominique sorrente, dotcom press, ebook, editrice pequod, edizioni arca felice, edizioni arcolaio, edizioni cfr, edizioni joker, edizioni kolibris, edizioni lietocolle, edizioni oèdipus, edizioni progetto cultura, elia malagò, elisa castagnoli, emilio capaccio, emilio coco, emilio villa, Enrico Cerquiglini, enrico de lea, enzo campi, eugenio montale, eventi, fabio orecchini, federico federici, filosofia, fotografia, francesco balsamo, Francesco De Girolamo, francesco iannone, francesco marotta, francesco muzzioli, franco fortini, gabriel del sarto, gabriella musetti, gemellaggio, georges bataille, ghérasim luca, giacomo cerrai, giampaolo de pietro, gianfranco fabbri, gianni toti, giovanna tomassucci, giovanni giudici, giovanni raboni, giuliano ladolfi editore, giuseppe samperi, giuseppe scapucci, haiku, hanno detto..., HOMEWORKS, ibrid@menti, ibrid@poesia, il foglio clandestino, incerti editori, inediti, italo calvino, ivano mugnaini, jane kenyon, john taylor, l'impero dei segni, lampi di stampa, la vita felice, le voci della luna, lorenzo mari, lorenzo pompeo, lucianna argentino, luigi cannillo, luigi di ruscio, maalox, maeba sciutti, mambo bologna, marco saya editore, maria pia quintavalla, marina pizzi, mario fresa, marsiglia, martha canfield, massimo pastore, matteo fantuzzi, matteo veronesi, maura del serra, maurizio cucchi, michel deguy, mostra, nanni balestrini, narda fattori, natalia castaldi, nathalie riera, news, note acide, noterelle, oboe sommerso, olivier bastide, palazzo albergati, paolo fabrizio iacuzzi, parole in coincidenza, paul celan, pensiero, piero bigongiari, pier paolo pasolini, pisa, pisa university press, pistoia, poesia, poesia americana, poesia di ricerca, poesia francese, poesia inglese, poesia ispanoamericana, poesia italiana, poesia lirica, poesia multimediale, poesia polacca, poesia spagnola, poesia sperimentale, poesia surrealista, poesia tedesca, poesia visiva, poetica, poeti dell'est, poetry slam, politica fragmenta, premio il ceppo, prufrock edizioni, puntoacapo editrice, questionario, raffaelli editore, raymond farina, recensioni, riflessioni sull'arte, riletture, rita florit, rita pacilio, riviste, roberto ceccarini, roberto veracini, roland barthes, rplibri, saggio, salvatore della capa, sandra palombo, scriptorium, sebastiano aglieco, semiologia, stefano guglielmin, stefano lorefice, surrealismo, t.s.eliot, teresa ferri, tradizione, traduzioni, transeuropa edizioni, ugo magnanti, umberto saba, valeria rossella, valerio magrelli, valérie brantome, video, viola amarelli, viviana scarinci, wallace stevens, wislawa szymborska, zona editrice
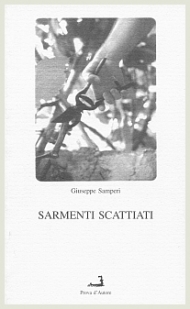 E non c'è di che vergognarsene.
E non c'è di che vergognarsene.




