Martedì, 10 luglio 2018
Sebastiano Aglieco - Infanzia resa, nota di Rita Pacilio
 Sebastiano Aglieco - Infanzia resa - Il Leggio
Libreria Editrice, 2018
Sebastiano Aglieco - Infanzia resa - Il Leggio
Libreria Editrice, 2018
Il bambino sviluppa da subito un legame affettivo con l’insegnante, il quale resta, comunque e da sempre, un punto di riferimento affettivo/comportamentale e di vicinanza. Il fattore di attaccamento (vedi teoria dell’attaccamento di Bowlby) garantisce al piccolo la sopravvivenza in un ambiente sociale in cui il bisogno di protezione è prioritario quanto la necessità di scaricare pulsioni e di alimentarsi. Nei primi scambi insegnante-bambino possono manifestarsi momenti di sconforto/conforto e segnali di richiesta di aiuto (contatto fisico, paura) esibiti dal bambino. Quindi, la relazione tra i due diventa struttura portante per la formazione cognitiva, psicologica ed emozionale del bambino, ma anche dell’adulto con cui tutti i giorni il piccolo viene in contatto. Infanzia resa, importante lavoro poetico di Sebastiano Aglieco, poeta e insegnante, non è un libro fiabesco, anzi. Ci troviamo di fronte a una struttura acquisita del conoscere la realtà semplice e affabile dei bambini in maniera civile e visionaria. Il libro è introdotto dalla prefazione dell’acuto Massimiliano Magnano e si conclude con una illuminante intervista curata da Vincenzo Di Maro. Sebastiano Aglieco, nella sua nota e nell’intervista, ha premura di accompagnarci nella lettura di alcuni testi e sezioni inserite nel libro (Collana Radici, Il Leggio Libreria Editrice, 2018 diretta da Gabriela Fantato); infatti, ci suggerisce, con tono pacato e naturale, di approfondire e soffermarci sui colori di alcuni passaggi a lui cari e mettendo a fuoco i piani universali della poesia, molto spesso persa nei labirinti superficiali della disattenzione. L’ambientazione è la scuola e i personaggi gli studenti: qui la poesia fa il suo ingresso come metodo di comunicazione, descrizione e azione autentica per identificarsi con il proprio e l’altrui animo. Un concreto nucleo di concentrazione del mondo come riferimento straordinario per esaltare immagini e pensiero: la tecnica espressiva del poeta ci educa al desiderio di indagare il vissuto sensoriale di ciascuno di noi, lettori/allievi, usando toni sacri dell’esperienza quotidiana al fine di evitare il rischio di allontanarci dalla vita. Aglieco imbastisce un canto delle origini di declinazione etica e umana in cui l’amore per la fedeltà al confronto assume sembianza analitica e incrocio/fusione di identità. Non è casuale incontrare il poeta bambino nell’adulto e l’adulto nel piccolo, una osmosi etica che riconsegna vita alla vita per osare la via diretta della verità. (rita pacilio)
Continua a leggere "Sebastiano Aglieco - Infanzia resa, nota di Rita Pacilio"
Martedì, 3 luglio 2018
Pietro Roversi - I pinguini dei tropici
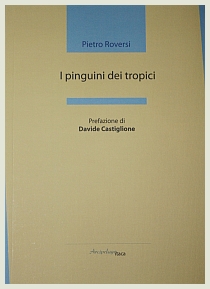
Continua a leggere "Pietro Roversi - I pinguini dei tropici"
Martedì, 26 giugno 2018
 Zhang Dalì, Meta-morphosis
(a Palazzo Fava a Bologna)
Zhang Dalì, Meta-morphosis
(a Palazzo Fava a Bologna)
E’ una storia di metamorfosi, di transizioni e ri-creazioni quella che
l’artista cinese contemporaneo Zhang Dalì racconta nella mostra attualmente
in corso a Bologna a Palazzo Fava, una storia in cui il senso di
cambiamento è pervasivo e a diversi livelli: politico ed economico nella
Cina globalizzata d’oggi, urbanistico nelle demolizioni e rifacimenti
massici della capitale, poetico nella capacità dell’artista di dare voce e
corpo alla transizione del paese verso una nuova forma di capitalismo
globale con tutti i traumi e contraddizioni che in esso si riflettono. Il
“realismo estremo” di Dalì esprime per l’artista la necessità di guardare
alla realtà d’oggi del suo popolo, del suo paese, e riflettere, esaminare,
dare voce a una coscienza critica, nella frattura anche tra realtà e
individuo perché, come egli afferma: “l’arte ha il dovere di esprimere il
proprio scetticismo verso la brutalità che esiste nel mondo reale”.
“Penso che l’artista contemporaneo senza una presa di posizione netta
non possa creare nessuna grande opera. Deve prendere una posizione che
gli permetta di distinguere tra bene e male e dare un giudizio di
valore. La creazione artistica incarna un’ideologia così come
un’umanità. Se non c’è compassione, amore ma solo l’idea di arte come
giullare di corte allora l’artista sarà uno snob e uno speculatore”[1]
.
L’arte contemporanea in Cina dal suo punto di vista può solo essere un’arte
di ribellione, perché senza tale presa di posizione sarà l’interesse a
condurre il gioco o la pura logica del profitto. L’artista, secondo Dalì, è
colui che riesce a dare una voce, una coscienza critica e espressiva a
quello che sente manifestarsi intorno a sè nel mondo nella società, nella
vita che lo circonda e al quale i molti non possono dare voce. Di qui, la
necessità di comunicare, condividere con la maggior parte o dare visibilità
al massimo grado attraverso la fotografia, l’installazione o i graffiti in
modo da rendere palese una verità o una visione che viene dal profondo
senza incorrere in una mistificazione del reale che conduce a in un’arte
elitaria, complessa o distaccata dalle persone.
Il mio volto è questo ritratto espanso e reso attraverso una miriade di punti, unità luminose, pixel quasi dell’immagine elettronica nella litografia stampata. Ricoperto dal marchio indelebile di un nome, logo di un’arma da fuoco e cancellato dalla medesima come dall’ evidenza esposta di una violenza innegabile per quanto celata, dissimulata in maniera sottile o resa invisibile nella società d’oggi. Tuttavia, anche, è uno sguardo che penetra e attraversa la fitta maglia di questa rete densa e occlusiva per vedere attraverso e giungere, incisivo come un obiettivo al punto focale dell’immagine, tale lo sguardo dell’artista sul reale.
Continua a leggere ""
Mercoledì, 20 giugno 2018
Jean-Pierre Duprey - Poesie

Continua a leggere "Jean-Pierre Duprey - Poesie"
Venerdì, 8 giugno 2018
Joan Josep Barceló i Bauçà - Collegamenti covalenti - Aletti
editore, 2017

Continua a leggere ""
Mercoledì, 30 maggio 2018
Luigi D'Alessio - Louis
Luigi D'Alessio - Louis - RPLibri 2017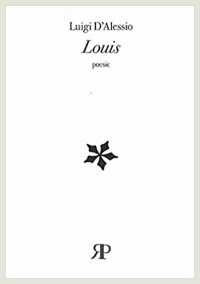
Continua a leggere "Luigi D'Alessio - Louis"
Venerdì, 18 maggio 2018
 “Revolutija
”, artisti russi tra avanguardia e rivoluzione (al Mambo di bologna)
“Revolutija
”, artisti russi tra avanguardia e rivoluzione (al Mambo di bologna)
“Revolutija” dal titolo della mostra al Mambo di Bologna, è lo spirito rivoluzionario che travolge e scuote nell’anno tumultuoso del 1917 una Russia millenaria e zarista nello sguardo di artisti d’eccezione come Kandinsky, Malevich, Chagall, Tatlin, Replin ecc. E’ ancora il fervore culturale, lo spirito della modernità, l’anima dell’avanguardia nei suoi diversi movimenti che tra il 1910 e il 1920 rinnovano profondamente il volto dell’arte attraverso un’ondata di creatività che come una ventata violenta e travolgente precorre il rovesciamento politico del paese, lo esalta e lo condivide. Da un punto di vista artistico assistiamo al concepimento di “forme creative che maturano attraverso i decenni” e si inseriscono pur nella loro diversità in quel progetto di rinnovamento estetico radicale delle avanguardie europee. Politicamente, la rivoluzione è il centro nodale e l’apice di un pensiero nuovo, marxista e leninista di ispirazione che sfocerà nel rovesciamento dell’ordine stabilito, la fine di un mondo e l’inizio, brutale, incerto e imprevedibile di un altro per giungere più tardi alla sua involuzione totalitarista negli anni ‘30.
Nell’immagine d’apertura “Che vastità” (1905) di Il’ja Repin in maniera
quasi surreale due giovani appaiono sospesi in un turbinio d’onde in mezzo
all’oceano; si lasciano trasportare, il cappello di lei svolazzante
trattenuto a da una mano contro le ondate tempestose e il vorticare
dell’aria marina, lui euforico con le braccia aperte e il torace portato
verso l’avanti come per accogliere o sfidare le forze incontenibili dei
mari e dei venti. Inebriati, quasi sospesi contro il vasto scrosciare delle
onde nel moto tumultuoso dell’oceano appaiono scivolare sulle acque
visibilmente rapiti dall’entusiasmo per la ventata di nuova libertà.
L’uragano spontaneo e travolgente come estasi ai sensi preannuncia un tempo
nuovo, una scintilla accesa nell’oscurità, l’idea di un movimento
sotterraneo se non emerso ancora , che come questi fiotti si approssima
impossibile ad arrestare.

Repin, “17 ottobre 1905”
Volti vividi, realismo e passione, Repin coglie in questo grande affresco
della classe liberare “il carnevale della rivoluzione russa pieno di
follia, colori e beatitudine” mentre si festeggia l’alba di un nuovo
secolo, agli albori di un moto del 1905 che sfocerà dodici anni più tardi
nella rivoluzione d’ottobre. Una folla di volti di diverse età e
provenienze, entusiasti e liberali, nobili o borghesi, studenti, operai e
ufficiali cantano versi rivoluzionari in primo piano nell’affresco di una
società in ebollizione che incarna euforicamente lo spirito del nuovo,
irriverente e vitale alle porte. I volti nitidi ed esuberanti appaiono
rapiti un una sorta di estasi collettiva di cui il fervore politico permea
l’ area e aleggia tra le linee, dietro gli sguardi, ovunque tacito
attraverso la scena.

Continua a leggere ""
Lunedì, 14 maggio 2018
Rodolfo Zucco - Bubuluz, nota di Gabriella Musetti
«Raccolta di trascrizioni» e aggregazione in forma di pastiche in
molti casi, «centone di compos izioni precedenti di uno o più
autori» (dal Dizionario enciclopedico della musica e dei musicisti UTET),
così ci informa l'autore nella Nota a fine testo, citando un passo di
Jolanda Insana sul «bisogno di fare e disfare», e mettendo a commento
Raboni della “poesia che si fa”, Gli esercizi platonici di
Pagliarani, i Palimpsestes di Genette, Zanzotto...
izioni precedenti di uno o più
autori» (dal Dizionario enciclopedico della musica e dei musicisti UTET),
così ci informa l'autore nella Nota a fine testo, citando un passo di
Jolanda Insana sul «bisogno di fare e disfare», e mettendo a commento
Raboni della “poesia che si fa”, Gli esercizi platonici di
Pagliarani, i Palimpsestes di Genette, Zanzotto...
E in effetti questa raccolta, che si colloca dentro una tradizione antichissima, mette a punto alcune considerazioni specifiche sulle modalità del “fare poesia”:
- i rapporti di senso cambiano, ma reggono in altri modelli inediti e a volte imprevisti, scombinando e ricombinando il materiale verbale («si creano sbilanciamenti» osserva Insana a proposito di proprie esperienze simili);
- è un modo per «giocare con ciò che si trova in giro» (ancora Insana), quindi si pone attenzione alla disposizione a usare parole, oggetti, già in circolazione, comuni;
- più che esercizi di scrittura sono anche e forse soprattutto «esercizi di lettura», nel senso di lego (“leggere” e anche “scegliere”, “raccogliere”);
- questo disfare e fare ci riporta alla poesia come a «un piccolo o grande
opificio» (Zanzotto).
La ricombinazione di significati ha tradizioni lunghe nel tempo e consolidate nel Novecento, soprattutto in ambito francese, svizzero, tedesco (Oulipo, dadaismo, parte delle Avanguardie) e angloamericano.
Nella raccolta di Rodolfo Zucco diventa materiale di creazione e di studio,
esercizi di scrittura in cui si sperimentano multiformi possibilità di
costruzioni linguistiche per indagare fin dove può arrivare la forza di
aggregazione del linguaggio, la sua disponibilità plastica. E parimenti
quali immersioni nei significati sono possibili, quali suggestioni si
agganciano a una forma di scrittura non empatica, distaccata, tenuta
insieme dalla misura delle parole, anche quando si tratti di linguaggio
arcaico, specialistico, gergale, colloquiale, plurilinguistico. Le
“restituzioni” ci offrono un testo sorvegliato, misurato, mai dirompente o
eccessivo. Come se l'intento primo dell'autore fosse stato quello di
mantenere un equilibrio interno, una proporzione nel dicibile, lavorando di
scelta ponderata, di presa di misura negli accostamenti. Questo
procedimento non diminuisce la creatività, ma libera la disposizione
autonoma alla ricerca, senza eccessi o sovraccarichi derivanti da un
surplus empatico.
Non sono giochetti fini a se stessi o al più legati a una sovraesposizione di narcisismo (anche involontario), o di ironia, di quella arrischiata sorpresa accattivante atta ad attrarre il lettore, una manipolazione piuttosto superficiale che riveli bizzarrie, metta in luce la facilità del processo di invenzione, di imitazione, come in tanti esercizi di scrittura contemporanei.
In questa raccolta l'esplorazione del linguaggio consente due direttrici di percorso: una verticale, che entra nei gangli del processo creativo, si cala nelle profondità del soggetto perché muove qualche lontana somiglianza o reminiscenza o faglia sospesa che tende a risuonare nuovamente; un'altra orizzontale, aperta e dinamica, che esplora le disposizioni della lingua, le sue innumerevoli possibilità di combinazione da cui scaturiscono nuovi o rinnovati sensi, tutti indagabili in altre esplorazioni.
E non perché il materiale usato appartenga spesso alla lingua antica o a registri specialistici o comuni, a forme desuete o burocratiche, alla letteratura, a dizionari, a copioni teatrali, a codici di legislazioni, a resoconti di viaggi, alla produzione saggistica, a didascalie; e si rincorrano, tra gli altri, i nomi di Dino Buzzati, Bruno Schulz, Stefano Malatesta, Konrad Lorenz, Carlo Goldoni, si affacci forse Elena Ferrante.
Neppure perché si mantenga graficamente una separazione (tondo e italico) nella scrittura a indicare intenzioni diverse e qualche volta si rimandi a un gioco alterno, uno spostamento inaspettato nella “posizione” e nell'ottica scrittoria. E neppure perché da spunti appena accennati nascano per interna germinazione delle osservazioni, riflessioni, suggerimenti che trascinano il senso a interrogarsi sul comune destino, sulla disponibilità umana alla esistenza consumata nelle sue innumerevoli forme: come, in quali modi storici e contemporanei, è data, si è manifestata.
E' una osservazione continua di frammenti, di particelle di realtà accostati per moltiplicarne il senso, per dare significazione di una complessità di sguardi, di scelte, di posizioni, di proprietà, di accidenti, tutti oggetto di trasformazioni, mutazioni.
E lo sguardo combinatorio dell'autore sorveglia e scava la materia vitale con la cura tenace dello studioso, con l'accudimento dell'amante. (gabriella musetti)
Continua a leggere "Rodolfo Zucco - Bubuluz, nota di Gabriella Musetti"
Domenica, 6 maggio 2018
Europa in versi: il festival e alcuni testi degli ospiti
 Dal 18 al 20 maggio prossimi si svolgerà a Villa Gallia a Como l' VIII edizione del Festival Internazionale di Poesia "Europa in versi", con il tema "La poesia e il viaggio". Il programma (v. il comunicato stampa completo QUI) comprende, oltre la premiazione dei vincitori del “Premio Internazionale di Poesia e narrativa Europa in versi” (giuria composta da Milo De Angelis, presidente, Roberto Galaverni, Laura Garavaglia, Mario Santagostini, Elisabetta Broli, Andrea Tavernati e Wolfango Testoni), anche un reading di poeti provenienti da diversi paesi (Ion Deaconescu, Metin Cengiz, Dmytro Tchystiak, Claudio Pozzani, Francoise Roy, Massimo Daviddi, Gian Mario Villalta, Müsser Yeniay, Luciano Monti, Maddalena Lotter e Kabir Yusuf Abukar); e, per la prima volta al Festival, un poetry slam, coordinato da Dome Bulfaro, anch'esso con artisti di varia provenienza, i campioni nazionali di Usa (Regie Gibson), Francia (D' De Kabal), Sud Africa (Tania Haberland), Svezia (Olivia Bergdahl), Italia (Simone Savogin) e Spagna (Dani Orviz).
Dal 18 al 20 maggio prossimi si svolgerà a Villa Gallia a Como l' VIII edizione del Festival Internazionale di Poesia "Europa in versi", con il tema "La poesia e il viaggio". Il programma (v. il comunicato stampa completo QUI) comprende, oltre la premiazione dei vincitori del “Premio Internazionale di Poesia e narrativa Europa in versi” (giuria composta da Milo De Angelis, presidente, Roberto Galaverni, Laura Garavaglia, Mario Santagostini, Elisabetta Broli, Andrea Tavernati e Wolfango Testoni), anche un reading di poeti provenienti da diversi paesi (Ion Deaconescu, Metin Cengiz, Dmytro Tchystiak, Claudio Pozzani, Francoise Roy, Massimo Daviddi, Gian Mario Villalta, Müsser Yeniay, Luciano Monti, Maddalena Lotter e Kabir Yusuf Abukar); e, per la prima volta al Festival, un poetry slam, coordinato da Dome Bulfaro, anch'esso con artisti di varia provenienza, i campioni nazionali di Usa (Regie Gibson), Francia (D' De Kabal), Sud Africa (Tania Haberland), Svezia (Olivia Bergdahl), Italia (Simone Savogin) e Spagna (Dani Orviz). Come tutte le volte che mi è possibile pubblico per gli amici di IE una discreta selezione di poesie dei partecipanti, ringraziando con l'occasione Laura Garavaglia, presidentessa del Festival e della Casa della Poesia di Como, e gli autori per la concessione dei testi.
Ion Deaconescu
nasce nel 1947, è poeta, scrittore, romanziere, critico letterario e
traduttore. Si è laureato alla Facoltà di Lettere dell'Università di
Bucarest e alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Craiova. È
docente presso la Facoltà di Scienze Sociali della stessa città. La sua
poesia affronta spesso il tema dell’amore con toni lirici. Il suo sguardo
si allarga anche a riflessioni sul senso della vita e sull’esistenza di
Dio. È stato tradotto in moltissime lingue tra cui: francese, italiano,
portoghese, serbo, macedone, inglese, turco, ungherese. Ha pubblicato oltre
cinquanta volumi tra poesie, romanzi, critica letteraria e traduzioni,
ottenendo numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, quali il
premio Racin e il premio Trieste Poesia. È presidente dell’Accademia
Internazionale “Mihai Eminescu” e direttore del Festival di poesia omonimo.
Esiste veramente
Lei c’è, esiste veramente…
Semplice come fuoco di stelle nel cielo d’estate
La senti invadere selvaggia
Sopra di te
Un’altra volta calma ti accarezza le guance
E le ferrite della fiducia
Dopo il cessato divertimento dei cacciatori
E la preda è dimenticata, quasi ignorata.
Lei c’è.
Esiste veramente,
Cambia il silenzio
E frana il ponte sul quale l’arcobaleno passa
Il cuore della voce palpita in un’incerta speranza
E grida lo stesso silenzio in una lingua
Degna, profonda.
Sulla trasparente pianura dei sogni
Lei e l’ombra hanno sbagliato la stagione
E il corpo nato dallo spazio.
Lei c’è. Esiste veramente.
All’improvviso
Le cose intorno
stavano invecchiando
senza una spiegazione.
I vocabolari stavano avvizzendo.
All’improvviso la freccia dei tuoi occhi
che mi trapassa e poi mi fa risorgere.
Era una sera un poco strana, confusa,
Troppi versi detti in piazza
in un paese di cui ho perso il nome.
Metin Cengiz
nasce il 3 maggio 1953 a Göle/Kars (ora Ardahan), in Turchia. È poeta,
editore e scrittore e, tra l’altro, membro del Sindacato degli Scrittori
della Turchia. Dopo il golpe militare del 12 settembre 1980, è stato
imprigionato per due anni perché dissidente. Durante gli anni di
insegnamento della lingua francese nelle scuole di varie città turche, è
stato mandato due volte in esilio e sospeso dal lavoro per le sue idee
politiche. La sua poesia propone temi di grande attualità come le guerre in
Medio Oriente, le contraddizioni di etnie e religioni, l’esistenza
miserabile dei poveri nella società, l’ingiustizia e la compassione, la
libertà e la sua perdita. I suoi versi sono un atto di pace, ma con una
straordinaria potenza nella difesa della libertà, della giustizia e della
fraternità. Oltre che per i suoi libri è famoso per i suoi articoli sulla
poesia. È diventato uno dei pionieri del periodo poetico post 1980 in
Turchia.
Gaza
Ieri ho visto la morte, era senza ali
Era nell’aria, pioveva
Qui, tu sei a Gaza dove si è accampata la morte
L’aria sembra lacerata da un coltello
Il sole è un urlo cieco
I suoi occhiali tacciono
Gli alberi sono cadaveri
I minareti non si slanciano verso il cielo ma verso il nulla
I bambini, bambini, bambini di Gaza
Strade, mercati, case piene di bambini
Gaza con le sue sagome di bambini è un gigante che combatte il nemico.
Bambini che cantano nel grembo della morte
Bambini silenziosi come santi, religiosi come musulmani
Aspettano che si plachi la voce delle pallottole
Riempiranno i campi
e abbracceranno le loro morti senza ricordare la fame
Vecchie donne con tuniche
Case, strade, sorvegliano la vita spalla a spalla
La pazienza è dipinta sui loro volti
Senza speranza, arrabbiati, tristi, vendicativi
Come un urlo che si leva al cielo
Come promesse
Stanno come una parte di cielo
Qui, sei a Gaza
La morte a Gaza è come un gioco da bambini
È come mangiare pane e olive a colazione
È come l’amore dei giovani
La morte a Gaza è come una statua di bronzo
A cui guardano tutte le finestre
La morte lavora come la mente di Gaza
Qui, tu sei a Gaza
In fiamme
Dove la morte ha ingoiato la lingua
Gaza è come un palloncino esploso
Cosa possono fare i poeti Arabi
le canzoni puzzano di bruciato in Galilea
Gaza è un limone giallo in mezzo al deserto
Da un lato, è spremuto da mani invisibili
Con una pressa d’acciaio
Dall’altro, stanno i nemici
Come una nuvola di morte
Gli occhi di Gaza si sono asciugati per il pianto
Così ora da Gaza esce il cadavere di Dio.
Dmytro Tchystiak
ucraino, trentenne, è poeta, scrittore di racconti, critico letterario e
traduttore, accademico e giornalista. La sua poesia è caratterizzata da una
vena surrealista che coinvolge il lettore in una dimensione onirica, dove
l’inconscio affiora con immagini di forte impatto emotivo. È professore
alla National Taras Shevchenko Kyiv University, PhD, editore presso le case
editrici ucraine “Raduga” e “Summit-Knyga” e lettore di alcuni editori
francesi e belgi. Ha pubblicato quarantacinque libri, che gli hanno portato
alcuni premi nazionali e internazionali in Ucraina, Francia, Belgio,
Germania, Grecia e Romania. Ha tradotto molti scrittori slavi e francofoni
in ucraino e circa cinquanta scrittori in francese. È membro dell'Accademia
Europea delle Scienze, delle Arti e delle Lettere (Parigi) e membro
corrispondente dell'Accademia delle Scienze dell’Istruzione Superiore
dell'Ucraina.
Fiori
Ecco l'alba nel riflesso delle magnolie
tremante ti elevi nello spazio
ti alzi dal letto, dove siamo annegati
nel diluvio morboso (con questo dolore bianco,
e il grido rosso del viburno che trafigge i giovani,
i notturni), anzi non ti alzi,
fluttui come questo suono di clarinetto
così alto che la nota raggiunge la morte,
e al di là gli uccelli si svegliano e rispondono
e si direbbe che una mossa sia sufficiente
per esempio, aprire la finestra e tremare
oltre questo taglio di luce
per creare
l’alba!
Acacia
Camminavi sui fiori d’acacia
Senza sentire le voci della notte di primavera
Le mani incendiavano l’orizzonte
Passi tra i fiori d’acacia
e risuoni di notte e di maggio
il fuoco ha preso la tua voce per agitare una candela
Il vento è calato, canta solo
Un usignolo insoddisfatto
Le mani bianche tendono alla luna piena
E I fiori d’acacia fluttuano dolcemente tra le stelle.
Claudio Pozzani
nasce a Genova nel 1961, è poeta, narratore e musicista; è apprezzato in
Italia e all’estero per le sue performance poetiche nei più importanti
festival letterari e nei Saloni del Libro. La sua è una poesia performativa
e teatrale, dove emergono i temi dell’amore, della ricerca della propria
identità, in un continuo fluire tra dimensione del sogno e della realtà.
Nel 1983 fonda il Circolo dei Viaggiatori nel Tempo (CVT), un’associazione
culturale che si occupa di arte, poesia e letteratura. Tra le tante
iniziative promosse, il Festival Internazionale di Poesia di Genova “Parole
spalancate”. Nel 2001 crea la Casa Internazionale di Poesia sita a Palazzo
Ducale a Genova. Il suo CD di poesia e musica “La marcia dell'ombra” è
rimasto per oltre due mesi nella top 20 di preferenza delle radio
indipendenti italiane. Ha pubblicato inoltre il volume “Spalancati spazi –
Poesie 1995-2016” per Passigli Editore e le sue poesie sono tradotte e
pubblicate in oltre dieci paesi.
La marcia dell’ombra
Stanno cadendo corde dal cielo
e gelide catene ti danzano attorno
È un mondo di nodi
da sciogliere al buio
tra un lampo e l’altro
di fosforo e grida
È un groviglio di corde
che rifiutano forbici
E un pettine che s’incastra
dentro chiome che non pensano
È ombra... ombra
È un battito di ciglia ancora
Mi guardo attorno e vedo muri
persino il mio specchio è diventato un muro
sui tuoi seni è cresciuta una pelle di muro
il mio cuore, i miei sensi reincarnati in muri
E continuano a piovere preghiere e bestemmie
che evaporano appena toccan la sabbia
e continuano a strisciare in un silenzio velenoso
avverbi, aggettivi, parole senza suono
E ombra... ombra...
e un battito di ciglia ancora
Del sole vedo solo il suo riflesso
nelle pozze iridescenti di acqua piovana,
della luna indovino la presenza nel buio
dal lontano abbaiare dei cani legati
La mia pace non è la mancanza di guerra
La mia pace è l’assenza del concetto di guerra
Non ombra... ombra...
ma un battito di ciglia ancora
Sono
Sono l’apostolo lasciato fuori dall’Ultima Cena
Sono il garibaldino arrivato troppo tardi allo scoglio di Quarto
Sono il Messia di una religione in cui nessuno crede
Io sono l’escluso, l’outsider, il maledetto che non cede
Sono il protagonista che muore nella prima pagina
Sono il gatto guercio che nessuna vecchia vuol carezzare
Sono la bestia idrofoba che morde la mano tesa per pietà
Io sono l’escluso, l’outsider, il maledetto senza età
Sono l’onda anomala che porta via asciugamani e radioline
Sono il malinteso che fa litigare
Sono il diavolo che ha schivato il calamaio di Lutero
Sono la pellicola che si strappa sul più bello
Io sono l’escluso, l’outsider, un chiodo nel cervello
Sono la pallina del flipper che cade un punto prima del record
Sono l’autorete all’ultimo secondo
Sono il bimbo che ghigna contro le sberle della madre
Sono la paura dell’erba che sta per essere falciata
Io sono l’escluso, l’outsider, questa pagina strappata
Francoise Roy
nasce a Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada, nel 1959. È poetessa, traduttrice,
scrittrice, geografa e fotografa. Bilingue. Cresciuta in francese ma
istruita letterariamente in spagnolo, Francoise Roy ha il tocco lieve e
preciso di chi sente la precarietà dell'esistenza e, scrivendo, osserva con
partecipazione gli impercettibili cambiamenti del quotidiano. Ha vinto
numerosi premi a livello internazionale. Ha tradotto più di sessanta libri,
pubblicato tre romanzi, due libri di racconti, tre plaquette e quattordici
libri di poesie. È stata invitata a molti Festival di poesia in tutto il
mondo.
Mamma, tanto dura, e la frutta
We have lived too close for love […]. [She] has grown to be my shadow.
Do our shadows love us, for all that they are never parted from us?
J.M. Coetzee (Foe)
1. Spaghetti le mie ossa, sotto le pietre levigate,
il canto rotolato dei tuoi quattromila occhi.
2. Il mio cuore di origami, piegato nell'istmo delle tue
fauci: marmorea carta, e sempre, da sempre tuo.
3. Cammello nel deserto, annuso la vicinanza di un
ristagno di acqua: mai un luogo del tuo affetto.
4. Il tuo coltello brilla nella notte dell'occhio: filo di luna
nuova, perfetta iperbole delle tue pupille.
5. Rimenbranza di me, perla viva nel suo astuccio di
calcio: quell’organo tuo, cristallizzato corpo dentro.
6. Palpavi il mio cuore, avocado nel tuo campionario.
Meraviglia di frutte fantastiche: una mela magica,
rossa e senza picciolo, dove occultare le mie arterie.
7. La tua bara, madre, con una pietra dentro, sola, dura,
quando la tua carne intorno si sarà dissolta.
Le labbra
Due lune di carne rosa tra ultimo quarto e luna
nuova, unite da quella strana parola, "commessura", piccola
cucitura di un solo punto per imbastirle al viso.
Tremanti orchidee del corpo, pelle scamosciata del petalo, orlo
delle parole, sì, ma estranee al loro picchiettio sonoro, al loro
torchio, al loro velluto, al loro acido muriatico, ai loro coloriti
sciami di note.
Il loro unico compito è il bacio. Quello di Giuda, quello dell'addio, quello
del cuore che sotterrato nella sua gabbia di costole – fidanzato
di Afrodite –, sogna di sentire i loro bianchi sacramenti.
Forse Dio aprì di taglio all'uomo muto quella ferita
nel viso, dicendogli: “Parla!”.
Addendum: Sebbene possano essere descritte come la porta d’accesso dell’apparato digestivo, l’apertura della bocca, o si possa dire di esse che sono una membrana retrattile di pelle e muscoli, le labbra hanno prima di tutto una funzione seduttiva. L’azione più connotata delle labbra, dare un bacio, è un simbolo del dono di sé sul piano spirituale, riconciliazione, tenerezza, amore o venerazione (da qui l’abitudine di baciare i piedi, le reliquie e i vesiti dei santi). Le labbra simbolizzano anche il parlare e il silenzio, sebbene la fonazione non si generi lì, ma molto più in basso, e dentro il corpo.
Massimo Daviddi
nasce a Firenze nel 1954, trascorre parte della sua vita tra Milano e
Luino: da diversi anni risiede a Mendrisio, Cantone Ticino. Per Massimo
Daviddi la poesia è «quanto di più inutile esista, ma un’inutilità preziosa
perché costringe l’uomo ad aderire al mondo». La città, con i suoi
itinerari e le sue scoperte, diventa motivo di confronto tra le cose
abituali e l’uomo. La prima raccolta che pubblica nel 2000 è: “Zoo
Persone”. Grazie a “L’oblio sotto la pianta” del 2005, è stato finalista al
premio Viareggio Rèpaci. Testi inediti sono pubblicati nell’“Almanacco
dello Specchio” del 2007. Con “Il silenzio degli operai”, edizioni La Vita
Felice, gli è stato assegnato il premio Federale di letteratura. Ha
partecipato al Festival Internazionale della Poesia di San Benedetto del
Tronto e a quello di Genova. Ha tenuto letture a Milano, Roma, Heidelberg,
Ginevra. Il suo ultimo lavoro pubblicato nel 2017 è “Madre Assenza”.
Oltre la ramina
I
Bisognerebbe ascoltarli mentre vanno indietro uno dopo
l’altro a due passi dal confine, le ruote vicino alle pompe
di benzina, ai rilievi della montagna, migliaia di auto con
il profilo rovesciato dove il pensiero per sua natura torna
alle origini, si fa passato; seguirli è utile, là le prime case,
immagini devote, pietre e gradini su un piccolo giardino,
avventori al bar. Sapresti anche tu di più di te, conosceresti
il senso dello stare in fila, a macchia di leopardo senza nome.
II
Non abbiamo speranza, non conosciamo quale odore
spinga i cinghiali oltre la ramina, dove vanno esuli a mangiare
le bacche e come dicono molti a distruggere, non sappiamo
perché il carosello di branchi uniti dal desiderio venga vicino
alle nostre case, esca e scavalchi venendoci incontro, saltellando;
quale sia la pressione del sangue, le loro aurore, quale sia la violenza
vera, come dirla.
III
Le linee del campo di calcio sono state la nostra esistenza,
ho iniziato a Milano su un cortile fino a Pianazzo, segreto
tra le frontiere. Non si contavano le decine di maglie,
l’idea di tornare a casa che dava la vittoria e a Palone
grembiuli, fili di ferro, la terra e la notte.
Gian Mario Villalta
è professore di liceo, saggista e narratore. La poesia di Gian Mario
Villalta indaga il reale in modo guardingo, come se qualcosa stesse per
venire a mancare, o fosse appena venuto a mancare, ma forse nessuno se ne è
accorto. Il grande protagonista è soprattutto il tempo, un presente sospeso
tra passato irrinunciabile – pur senza deliquio nostalgico – e futuro
enigmatico. Il suo ultimo romanzo si intitola “Scuola di Felicità”
(Mondadori, 2015). Da molti anni segue il panorama poetico italiano e
dedica particolare attenzione all'opera di Andrea Zanzotto, collaborando al
Meridiano Mondadori e curando l'Oscar degli scritti letterari. Inoltre
scrive poesia e vince il Premio Viareggio 2011 con “Vanità della mente” (Mondadori). Il libro di poesia più recente è “Telepatia”
(Lietocollle, 2016). È direttore artistico di “Pordenone legge: festa del
libro con gli autori”.
Quando ero ragazzo, alla fattoria, dopo il ponte,
gli animali nella stalla, dentro il pollaio e il cane
alla catena tutta la notte intrecciavano i fremiti
sottopelle, i fiati, i sussurri al mio respiro,
fino a quando mi univo sommerso nell’onda
del loro sonno o quando un grido
avvertiva che altri animali, selvatici,
la donnola o il gufo, erano entrati nei nostri sogni.
Poi l'abbaiare, i tonfi, le imposte aperte
sul freddo. Il padre: “Inutile, a quest’ora,
tornare a dormire”. Il sonno invece avvolgeva
presto di nuovo me, i miei fratelli, gli animali,
e la casa e il fienile e il pollaio si incurvavano lievi,
lievitando verso l’alone della luna.
Ancora un minuto, un minuto.
Mi riconosce una fuga di echi.
La proroga tra l'essere
chiunque e il diventare me stesso
dura l'incalcolabile.
***
Ho una sveglia che ha il suono ostile
dei vecchi telefoni grigi, quelli
di quando abitavo nel mio paese,
con le cifre nella rotella dentro i buchi.
Una roulette dove punto ogni giorno
lo stesso numero e il sei esce storto.
L’ho presa dai cinesi: spero confonda
L’oroscopo – vergine e topo, bilancia e drago –
e ogni volta che squilla sogno qualcuno
che solleva al posto mio l’apparecchio
e sa cosa rispondere.
Müesser Yeniay
nasce a Izmir nel 1984. In Turchia vince molti premi letterari. I suoi
versi, studiati e calibrati, sono permeati di femminilità e ribellione e
tesi alla volontà di riaffermare la sua natura biologica e umana di donna,
la riscoperta del significato autentico e della reale diversità tra uomo e
donna. I suoi libri di poesia sono stati tradotti e pubblicati negli Stati
Uniti, in Ungheria, Francia, India, Colombia, Spagna e Vietnam. Ha vissuto
in America e a Hong Kong. Müesser è inoltre editrice della rivista Diirden.
Al momento si occupa del PhD in turco alla Bilkent University di Ankara.
Conversazione continua con l’amato
Mi sono aperta a te
come i denti di
una cerniera
uno per uno
mi sono spezzata
a metà
quando mi hai toccata
ho visto la gloria
della terra
[nelle tue mani
ci sono piccole
fate volanti]
hai visto quel
dolce vuoto in me
il mio corpo come neve che si scioglie
fuso con il tuo corpo.
Amore
Ho un altro corpo
fuori di me
lo chiamano
amore
(ma questo è dolore)
se ti ho tenuto nel mio corpo
solo dopo ho sentito
così tanto
la tua esistenza
Continua a leggere "Europa in versi: il festival e alcuni testi degli ospiti"
Sabato, 28 aprile 2018
Alessandro Silva - L'adatto vocabolario di ogni specie
 Alessandro Silva - L'adatto vocabolario di ogni specie -
Edizioni Pietre Vive, 2016 - Illustrazioni di Giovanni Munari
Alessandro Silva - L'adatto vocabolario di ogni specie -
Edizioni Pietre Vive, 2016 - Illustrazioni di Giovanni Munari
Continua a leggere "Alessandro Silva - L'adatto vocabolario di ogni specie"
Martedì, 17 aprile 2018
Gabriele Galloni - In che luce cadranno, nota di G.D.V.
Gabriele Galloni corre da solo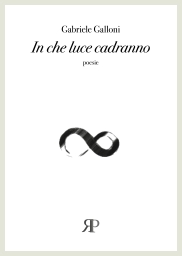
Metto le mani avanti. Non sono giovane e non sono poeta, benché qualche mio verso sia stato tempo addietro (tanto!) fortuitamente accolto in riviste come Nuovi Argomenti o Paragone – e chi si ricorda la gloriosa Il cavallo di Troia?
Non sono dunque poeta, ma appassionato lettore indubbiamente sì. E ancora oggi, tra acciacchi di ogni tipo, mi avventuro quotidianamente nella giungla delle nuove pubblicazioni poetiche. Prediligo i giovani, perché di leggere i quarantenni o i miei coetanei poco mi frega.
Leggo i giovani perché cerco, leggendoli, di provare ancora un poco l'invidia che a vent'anni mi spingeva a voler superare tutto e tutti.
Io non ci sono riuscito mai. Gabriele Galloni sì.
In che luce cadranno (RPlibri, 2018) è stato, dapprincipio, il consiglio svagato di una cara amica poeta. Poi, a lettura ultimata, il libro che ha ridefinito per me il concetto di Sacro. E non esagero: per giorni ho meditato sulla musica di Galloni come qualcun altro avrebbe potuto meditare sul Libro dei Salmi o sul Talmud. Meditazioni circolari, da sbronza apollinea più che dionisiaca.
Possibile, mi sono detto, che un ventiduenne, un millennial come
si dice oggi, sia stato in grado di sondare queste profondità? E chi gli ha
permesso di portare con sé questi detriti di lune sconosciute? A quali e
quante divinità ctonie ha chiesto udienza?
Invidio profondamente Galloni, non lo nascondo. Molto ho rimesso in
discussione con il suo libriccino. Ho pensato che una qualunque Verità
ultraterrena, su noi e sui nostri predecessori, l'avesse colta ed espressa
meglio lui in quaranta brevi poesie che migliaia di filosofi pensatori e
teologi in tomi e tomi d'angoscia. Ma un poeta non è portatore di Verità –
e sono certo che a Galloni dispiacerebbe questo mio volo pindarico; forse
ne riderebbe.
La cosmogonia galloniana non ha universi altri di riferimento.
Immagino quante salme, sue e solamente sue, lo abitino giorno e notte. I
suoi amati corpi che, ritornati alle cellule, rinascono nella luce
abbagliante di un verso perfetto, di un fulmen in clausola che tutto
ribalta come nel gioco dei dadi, nello scherzo tragico di un baro
caravaggesco.
In che luce cadranno
parte dall'epigramma (sfiorando sovente la narrazione), attraversa
l'idillio e approda a un obliquo teatro della coscienza. Su tutto il libro,
inestinguibile, quella che Baeumker teorizzò come Metafisica della Luce. Non mi sovvengono paragoni contemporanei
con il lavoro di Galloni. Forse i suoi parenti più prossimi sono i lirici
greci da bambini; forse certi mistici medievali le cui opere non sono mai
giunte a noi.
Un libro importante, In che luce cadranno. Tra i più rilevanti di
questi ultimi anni e della sua generazione. Poi staremo a vedere. Per ora, la poesia italiana ricomincia anche da qui. (Giovanni D.V.)
***
I morti tentano di consolarci
ma il loro tentativo è incomprensibile:
sono i lapsus, gli inciampi, l'indicibile
della conversazione. Sanno amarci
con una mano – e l'altra all'Invisibile.
***
Si parlava dei morti. Sulla tavola
i resti sparsi della cena – quelle
bistecche appena cotte. Il frigorifero
in segreto colloquio con le stelle.
***
Così un giorno, per caso,
i morti costruirono
il primo cimitero sotto il mare.
Se ne dimenticarono
in un tuffo soltanto.
Gabriele Galloni
è nato a Roma nel 1995. Studia Lettere Moderne all'Università La Sapienza.
Ha pubblicato Slittamenti (Augh Edizioni, Viterbo 2017) con una
nota di Antonio Veneziani.
Lunedì, 9 aprile 2018
John Taylor - L'oscuro splendore
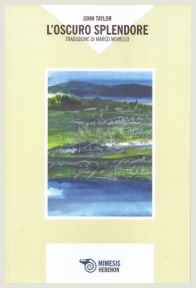 John Taylor - L'oscuro splendore - Mimesis Edizioni, collana
Hebenon
John Taylor - L'oscuro splendore - Mimesis Edizioni, collana
Hebenon
Continua a leggere "John Taylor - L'oscuro splendore"
Martedì, 27 marzo 2018
Antonis Fostieris - Nostalgia del presente
Il suono del mondo
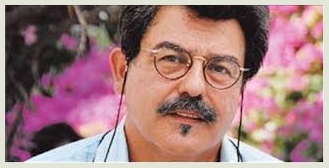
Mia piccola ammaliatrice non respingere il mio amore
Sappi comunque che non ti amo. E se ti hanno cantata
I poeti di ogni tempo, se ti hanno celebrata
Sulle loro cetre dalle corde di crine
Sappi dunque che i poeti sono tutti segaioli
Altrimenti non si lascerebbero
Chiamare poeti. Posa
La tua mano delicata d'acqua e di vento
- Non ti dicevano così i buffoni? -
Sulla mia fronte. La febbre
La temperatura naturale di un corpo
Che orina sull'alloro e dispregia il fruscio
Dello spirito che esala. Posa
Il tuo capezzolo sulle mie labbra
E lascia che la mia lingua lecchi silenziosa
Il vaso del tuo brivido. Piccola ammaliatrice
Con le poesie non si raggiunge l'orgasmo
Neppure i babbei che intorno a te rovesciano
Gargarismi di parole. Ascolta
Il muggito, il fragore, il pianto:
Di simili suoni è fatto il mondo. Ascolta
Il gracchiare - o il ruggito
Del leone che è il mondo. Ascolta
Il rombo dell'oceano; il rombo;
Non il canto spensierato dei pescatori.
Genesi
Quanto più procedevo nella luce
Impallidivano i colori
Si addensavano, vorticavano come un disco
Diventavano
Quel colore che non era più
Colore.
Nel cuore della notte un diramarsi di strade
Un aprirsi a nuove combinazioni
Dissi "buio" ed ecco generata
La terra con le sue piante i suoi animali
Invisibili enormi delicati
Che mi somigliano.
Continua a leggere "Antonis Fostieris - Nostalgia del presente"
Lunedì, 19 marzo 2018
Villa Dominica Balbinot - inediti da I FIORI ERANO FERMI - E LONTANI
Villa Dominica Balbinot mi ha mandato questi testi qualche tempo fa,
chi edendomi che ne pensassi. Li ho letti con un certo interesse, perché
indubbiamente escono un po' dagli schemi, se si va oltre una impressione
non del tutto peregrina di forme crepuscolari innestate con dosi massicce
di simbolismo. Il primo appunto che ho preso, scritto a margine, è stato
per la verità "poesia barocchetta". Volendo forse significare con questo
non solo una scrittura con forti circonvoluzioni e priva di spazi aperti ma
anche dove il paesaggio, inteso in senso lato sia come naturale che umano,
si defila, a favore della costruzione, o si rappresenta come un fondale o una quinta, in una maniera che mi
ricorda l' Isola dei morti di Arnold Böcklin. In realtà qui, restando al barocco, c'è sì molta
complessità ma poco capriccio, perché il tema o quanto meno l'atmosfera prevalenti sono compatti e
concentrati, tendono a dare al lettore (e qui si torna al simbolismo) il suggerimento di una visione assai convinta e personale del mondo. Che è certo, coma
annota Anna Maria Curci (altre poesie appartenenti a questo blocco sono
state presentate su Poetarum Silva) un "mondo dissestato, funestato", per
quanto di "straniata bellezza", su cui Balbinot getta "una luce che non
teme di essere cruda". Sulla crudezza possiamo essere d'accordo, almeno se
si tiene conto del lessico e relativi annessi usati dall'autrice in
funzione espressionistica (e vale il breve accostamento che ancora Curci fa
a Gottfried Benn - si parva licet però): qui troviamo silenziato omicidio, acque fresche e pericolose, carnarie mosche, eterno gennaio, terreno
insanguinato, bagliori lucidi e freddi, qualcosa...di cruentemente esatto,
patiboli reconditi, leucemica fragilità, narrazione del sangue, consuntore
morbo, dissezione delle cose maestose, anni di espiazione e delle cerimonie
esequiali, esasperata desolazione, degenerativo stato, camera dei suicidi in un albergo, l'innominata carne ferita dei morti, e così via. Ma non è tanto una questione di sintagmi quanto di
costruzione anche sintatticamente complessa di un testo che definirei, per
usare parole della stessa autrice, "livido e sontuoso e torbido" (quindi se
barocco c'è, verrebbe da dire con una battuta, è barocco spagnolo). In
aggiunta a queste ultime parole citate, a volte si ha l'impressione che in
un certo qual modo Balbinot parli criticamente di sé quando scrive di
"estetismo nero e profetico" (o forse profetizzante, direi), o di "vasto mondo
crespuscolare". Ma anche in questi rari casi di espressioni didascaliche e
forse un po' ingenue l'obbiettivo è il tratteggio di una atmosfera
perturbante in cui il lettore deve accettare di permanere o no. Possiamo
aggiungere a queste cose un uso programmatico del lei (terza persona) come soggetto sostituto del tu (che come sappiamo è un ulteriore camuffamento dell'io poetico) e a volte
forme verbali al passato che accentuano abilmente uno straniamento di tipo
temporale e un senso di definitivo e tuttavia attuale. Immagino che questa lei sia l'autrice, immersa nel suo "mondo", che è di volta in volta "della
realtà", "crepuscolare" ma "aperto da ogni parte" (corsivo dell'autrice), "di silenzio", "bluastro", ma più che altro
"grigio" o di una "debole colorazione ossidata - di un metallico paesaggio" (c.vo aut.) e di svariate altre connotazioni. Ma soprattutto un mondo in
cui si avverte come una presenza di forze esterne non del tutto chiare né
del tutto controllabili, un mondo molto poco popolato, solo da lei, e da essi che se capisco bene non sono tanto "altri" quanto un "noi", cioè un plurale
di quello stesso lei, una condivisione dell'angoscia e forse il dolore che pervadono l'ambiente
e di cui l'ambiente è proiezione. E poi i morti, evocati non solo
direttamente ("nella loro innominata carne ferita") ma anche sotto forma di
aggettivi (morti occhi, vie, fiori, foglie, cime), o come correlati
semantici (mortalità, uccisioni, ad esempio). Insomma Balbinot ha
sviluppato un suo stile, con una certa accuratezza linguistica, con molti
echi, che aderisce bene alla tematica che si è scelta, e che in pari
misura, va da sé, può generare interesse o respingere. Per concludere: se
si aggiungono caratteri anche indubbiamente romantici come un certo senso
dell'assoluto o una certa irrazionalità o un'idea di sublime che sovrasta
l'uomo, allora cos'è che tiene insieme e fonde il barocco, il crepuscolare,
il simbolista, l'espressionista, il romantico? in altre parole cos'è la
poesia di Villa Dominica Balbinot? Ma è ovvio: è poesia gotica. (g. cerrai)
edendomi che ne pensassi. Li ho letti con un certo interesse, perché
indubbiamente escono un po' dagli schemi, se si va oltre una impressione
non del tutto peregrina di forme crepuscolari innestate con dosi massicce
di simbolismo. Il primo appunto che ho preso, scritto a margine, è stato
per la verità "poesia barocchetta". Volendo forse significare con questo
non solo una scrittura con forti circonvoluzioni e priva di spazi aperti ma
anche dove il paesaggio, inteso in senso lato sia come naturale che umano,
si defila, a favore della costruzione, o si rappresenta come un fondale o una quinta, in una maniera che mi
ricorda l' Isola dei morti di Arnold Böcklin. In realtà qui, restando al barocco, c'è sì molta
complessità ma poco capriccio, perché il tema o quanto meno l'atmosfera prevalenti sono compatti e
concentrati, tendono a dare al lettore (e qui si torna al simbolismo) il suggerimento di una visione assai convinta e personale del mondo. Che è certo, coma
annota Anna Maria Curci (altre poesie appartenenti a questo blocco sono
state presentate su Poetarum Silva) un "mondo dissestato, funestato", per
quanto di "straniata bellezza", su cui Balbinot getta "una luce che non
teme di essere cruda". Sulla crudezza possiamo essere d'accordo, almeno se
si tiene conto del lessico e relativi annessi usati dall'autrice in
funzione espressionistica (e vale il breve accostamento che ancora Curci fa
a Gottfried Benn - si parva licet però): qui troviamo silenziato omicidio, acque fresche e pericolose, carnarie mosche, eterno gennaio, terreno
insanguinato, bagliori lucidi e freddi, qualcosa...di cruentemente esatto,
patiboli reconditi, leucemica fragilità, narrazione del sangue, consuntore
morbo, dissezione delle cose maestose, anni di espiazione e delle cerimonie
esequiali, esasperata desolazione, degenerativo stato, camera dei suicidi in un albergo, l'innominata carne ferita dei morti, e così via. Ma non è tanto una questione di sintagmi quanto di
costruzione anche sintatticamente complessa di un testo che definirei, per
usare parole della stessa autrice, "livido e sontuoso e torbido" (quindi se
barocco c'è, verrebbe da dire con una battuta, è barocco spagnolo). In
aggiunta a queste ultime parole citate, a volte si ha l'impressione che in
un certo qual modo Balbinot parli criticamente di sé quando scrive di
"estetismo nero e profetico" (o forse profetizzante, direi), o di "vasto mondo
crespuscolare". Ma anche in questi rari casi di espressioni didascaliche e
forse un po' ingenue l'obbiettivo è il tratteggio di una atmosfera
perturbante in cui il lettore deve accettare di permanere o no. Possiamo
aggiungere a queste cose un uso programmatico del lei (terza persona) come soggetto sostituto del tu (che come sappiamo è un ulteriore camuffamento dell'io poetico) e a volte
forme verbali al passato che accentuano abilmente uno straniamento di tipo
temporale e un senso di definitivo e tuttavia attuale. Immagino che questa lei sia l'autrice, immersa nel suo "mondo", che è di volta in volta "della
realtà", "crepuscolare" ma "aperto da ogni parte" (corsivo dell'autrice), "di silenzio", "bluastro", ma più che altro
"grigio" o di una "debole colorazione ossidata - di un metallico paesaggio" (c.vo aut.) e di svariate altre connotazioni. Ma soprattutto un mondo in
cui si avverte come una presenza di forze esterne non del tutto chiare né
del tutto controllabili, un mondo molto poco popolato, solo da lei, e da essi che se capisco bene non sono tanto "altri" quanto un "noi", cioè un plurale
di quello stesso lei, una condivisione dell'angoscia e forse il dolore che pervadono l'ambiente
e di cui l'ambiente è proiezione. E poi i morti, evocati non solo
direttamente ("nella loro innominata carne ferita") ma anche sotto forma di
aggettivi (morti occhi, vie, fiori, foglie, cime), o come correlati
semantici (mortalità, uccisioni, ad esempio). Insomma Balbinot ha
sviluppato un suo stile, con una certa accuratezza linguistica, con molti
echi, che aderisce bene alla tematica che si è scelta, e che in pari
misura, va da sé, può generare interesse o respingere. Per concludere: se
si aggiungono caratteri anche indubbiamente romantici come un certo senso
dell'assoluto o una certa irrazionalità o un'idea di sublime che sovrasta
l'uomo, allora cos'è che tiene insieme e fonde il barocco, il crepuscolare,
il simbolista, l'espressionista, il romantico? in altre parole cos'è la
poesia di Villa Dominica Balbinot? Ma è ovvio: è poesia gotica. (g. cerrai)
Continua a leggere "Villa Dominica Balbinot - inediti da I FIORI ERANO FERMI - E LONTANI"
Lunedì, 12 marzo 2018
Luigi Fontanella - Lo scialle rosso
 Luigi Fontanella - Lo scialle rosso - Moretti e Vitali, 2017
Luigi Fontanella - Lo scialle rosso - Moretti e Vitali, 2017
Nove poemetti o racconti in versi, scritti tra il 1999 e il 2014, ci dice in una nota lo stesso autore. Con una buona misura di anglosassone understatement, direi. E in effetti la prima cosa che salta agli occhi alla lettura di questi ampi testi lirici è come una necessità non solo di narrare una serie di eventi ma anche quella di fissarli, prima, come sopra una lastra e piegarli poi, modificarli e in sostanza gettarli sotto una nuova luce. Come si sa, infatti, ogni fenomeno varia e si modifica sotto l'occhio, magari innamorato, del suo osservatore. E' quello che fa sempre la poesia, la poesia buona, come atto di ricezione di ogni accidente, di ogni brandello di vita: diventare qualcosa d'altro, se non addirittura qualcosa di altri. Niente, per un poeta, trascorre inutilmente. Vige insomma, come scrive Paolo Lagazzi nella prefazione al libro, una "intermittente, appassionata, tenace memoria". Ricordare che sono tutte connotazioni che ci rimandano tra diversi altri a Montale è pleonastico, tanto più per Fontanella, tra le altre cose professore di Letteratura italiana alla New York State University (Lagazzi cita anche Savinio e Landolfi). Insomma, è la sua materia ed ogni eco non è altro che un indizio culturale scevro da qualsiasi epigonismo, uno strumento che si adatta perfettamente allo scopo. Come anche naturale, mi pare, è la vicinanza di Fontanella ad una consolidata tradizione letteraria non solo novecentesca, lirica soprattutto, ma che tiene ben presenti tutti gli sviluppi stilistici, appunto anche in senso narrativo e di aderenza al quotidiano, che soprattutto nel Novecento sono avvenuti.
Se i richiami, più o meno soffusi, possono essere quelli che abbiamo detto, [tuttavia] qui non c'è molto di "occasionale" e non solo per la dimensione testuale delle poesie, che denota una articolata elaborazione del materiale poetico di partenza, ma anche perché questa poesia nell'evento non si conclude, non diventa epifenomeno di qualcosa che ha colpito l'autore, dirottando magari verso un esercizio di stile, è decisamente antirapsodica, come se esplicitasse la convinzione che l'occasione, se vi è, contiene una "storia" (statica, diciamo) e un seme (dinamico), in altre parole rimanda ad altre e ben diverse considerazioni, non necessariamente soltanto "poetiche". Per quanto la memoria, in tutto il libro, sia elemento naturale fondamentale, essa non è pura rimembranza, sia per l'apporto della rêverie, come annota Lagazzi, in costante dialogo con una realtà oggettuale, sia perché Fontanella ha chiari i suoi obbiettivi poetici. Che mi pare siano quelli di evidenziare una dimensione spirituale degli eventi, per quanto eminentemente laica, e un loro ethos, cioè, letteralmente, un luogo in cui vivere, in altre parole (e non è certo un truismo) la vita medesima. Per cui il fatto, nella dimensione poetica, diventa qualcosa di rizomatoso, per dirla con Deleuze, il fatto, per sua definizione "passato" e tuttavia non muto, rivive di un'altra vita.
A me pare che si tratti di qualcosa di diverso dall'epifania, dall'agnizione o da un momento meramente ispirativo. Non è qualcosa di cui l'autore dice ah, bene, ecco un frammento di vita di cui può valere la pena scrivere, o non soltanto. Mi pare che questa scrittura diffusa, così fortemente fàtica, che descrive le cose nel loro aspetto sensibile e in quello meno evidente, sia un tentativo di ridefinire certi confini, che sono soprattutto tra la vita stessa (vissuta e - scrivendo - rivissuta) e la morte come luogo in cui non è più possibile dire. Potremmo definire tutto ciò semmai come una rivelazione, un disvelamento di implicazioni che però non provengono da nessun iperuranio, o da un''ispirazione di tipo romantico. Semplicemente già c'erano, sotto lo sguardo niente affatto passivo del poeta, che è facile che magari impropriamente ci ricordi, nel suo peregrinare per le strade di Firenze o New York, una certa flânerie baudelairiana. Uno sguardo inoltre che in molti di questi componimenti è condiviso, non solo con il lettore ma anche con chi, quasi sempre, è testimone dell'evento insieme all'autore. E se non ci sono testimoni, in queste narrazioni, ci sono personaggi letterari, gente incontrata per strada, amici e colleghi citati, exerga e rimandi letterari, che concorrono ad ampliare lo sguardo sulle cose. Sotto questo punto di vista potremmo dire che in questi testi non c'è una visione strettamente "privata", poiché mi pare che Fontanella non vi cerchi una catarsi personale, o una purificazione dell'esperienza dal prosaico a beneficio di un ipotetico lettore, ma che dia voce, per tutti, al possibile, soprattutto al possibile significato delle cose. In altre e diverse parole, non estetizza il suo materiale, e questa è una delle caratteristiche del suo stile.
Il poemetto eponimo, Lo scialle rosso, è emblematico dell'approccio di Fontanella alla sua materia. In una piovosa e ventosa giornata di fine Aprile, lo scialle rosso della accompagnatrice del poeta vola giù da un ponte di Ottawa. L'accadimento si esaurisce subito, lo scialle rosso scompare dalla scena, per fare posto in sostanza ad un sentire, a un sentimento del tempo che poi lo scialle, che riappare negli ultimi versi, avvolgerà simbolicamente, proteggendolo e chiudendo il cerchio. In mezzo Fontanella sviluppa una canzone sulla fragilità, rispetto al caso, al mondo o all'essere altrove, la fragilità individuale, e tuttavia la resistenza, della poesia soprattutto, come emblema di un nucleo forte dell'uomo. Le intemperie, anche simbolicamente intese, sul ponte di Ottawa "sbriciolano" il gruppetto di amici poeti (e testimoni, si diceva), lì presenti, come Davide Rondoni, Plinio Perilli, Irene Marchegiani, e scomparsi, come Giovanna Sicari, e lontane evocazione italiane. Ma sappiamo che tutti, o almeno la poesia che rappresentano, si ritroveranno. Lo scialle rosso quindi appare essere, come dicevo, non tanto un elemento epifanico e nemmeno un correlativo, quanto un potente marcatore mnemonico, in più carico dei segni del colore e del volo, da cui l'autore procede a costruire il suo impasto di narrazione e sogno. Nel quale la memoria non si esaurisce ma si rinnova come rappresentazione e immaginazione (lo stesso Fontanella rammenta, in una nota, il "connubio, che mi è caro, oscillante tra immaginazione e memoria, così come ne parla André Breton nel saggio Situazione surrealista dell'oggetto"), pur essendo questa poesia, va detto, ben lontana da territori surrealisti o anche simbolisti. Naturalmente questo registro, che si ripresenta anche in altri poemetti importanti come Dittico praghese e The old town, non è l'unico di cui dispone l'autore. In altri testi, che per alcuni aspetti preferisco, come Lettere al padre e Canto del distacco, il tono è più eminentemente lirico/elegiaco, o forse nervaliano come dice Fontanella, ma certo più venato di un intimo e privato sentimento di rimpianto, una affettività che in un certo senso ci avvicina maggiormente al poeta, testi in cui si allenta un poco la vena descrittiva, meno assiepati di "oggetti" e di nomi, un linguaggio che non ha necessità di articolarsi in narrazione o di dire "tutto" (come ad esempio in Old Town e Efemeridos) perché lavora sul piano di una percezione pura o se volete di un'empatia in cui gioca più il cuore che l'intelletto. (g. cerrai)
Continua a leggere "Luigi Fontanella - Lo scialle rosso"
Amministrazione
Ricerca veloce
ARCHIVIO GENERALE
Recent Entries
- Sebastiano Aglieco - Infanzia resa, nota di Rita Pacilio
- Pietro Roversi - I pinguini dei tropici
- Jean-Pierre Duprey - Poesie
- Luigi D'Alessio - Louis
- Rodolfo Zucco - Bubuluz, nota di Gabriella Musetti
- Europa in versi: il festival e alcuni testi degli ospiti
- domenica, maggio 6 2018
- Alessandro Silva - L'adatto vocabolario di ogni specie
- sabato, aprile 28 2018





